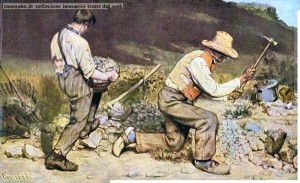 L’intellettuale “a colloquio” con il popolo nell’età postunitaria.
L’intellettuale “a colloquio” con il popolo nell’età postunitaria.
La lezione del Verga. CAPITOLO PRIMO
CAPITOLO PRIMO
1) Temperie storico-culturale- Il positivismo sociale:A Comte-H.Spencer-A.Gramsci e la funzione dell’intellettuale.
2) La questione meridionale- Le lettere Meridionali di P.Villari -La tesi di G.Fortunato- Le inchieste di Franchetti e Sonnino- La Prima Internazionale:Marx e Bakounin- Aspetti della questione sociale nel Meridione e nell’Europa: analogie e differenze attraverso l’analisi dei testi:incipit da “I Vecchi e i giovani” di L. Pirandello ed explicit da “Germinal” di E. Zola.- La questione meridionale nei giudizi di A.Nitti e A.Gramsci.
3) Giovanni Verga: tra storicità e letterarietà: breve excursus dell’opera verghiana. I principali contributi critici
1
Nell’età postunintaria avviene un fenomeno di rivolgimenti sociali, politici e
culturali, che appaiono in netta contraddizione con l’età idealistico-risorgimentale.
Vi è soprattutto un’attenzione al reale storico, di cui l’intellettuale si fa portavoce.
Possiamo affermare che il complesso delle condizioni storico-culturali si riflette nell’ambito dell’ideologia, ed, in specie, nell’attività teoretica dei pensatori ed in quella meramente artistica di letterati ed artisti.
L’intellettuale accentra il suo interesse sul conflitto tra borghesia e proletariato.
In effetti, nel periodo, che ci accingiamo a trattare, ad una borghesia, detentrice di poteri economici e di privilegi industrializzata, si affianca una piccola borghesia prevalentemente agraria, che opprime le classi meno abbienti e popolari, e, che, come osserva il Verga, vengono travolti dalla fiumana del progresso.
Si delinea, inoltre, il divario tra Nord e Sud.
Ne consegue che molti lavoratori meridionali sono sottoposti ad una fatica disumana nei campi, nelle miniere o nella pratica della pesca, ricavando un miserevole guadagno, non sufficiente spesso alla loro stessa sopravvivenza.
Le figure di Rosso Malpelo nel Verga e di Ciaula in Pirandello sono un’esemplificazione di questo status socio-economico.
Non solo in Sicilia, inoltre, il vulnus, prodotto dalla sperequazione sociale tra classe borghese e proletariato, si fa sentire, ma anche nel Nord ed in tutta quanta l’Europa.
L’espansione capitalistica, prodotta dall’incremento dei mezzi di lavoro meccanizzati ed industrializzati, crea una massa ingente di proletariato.
Le macchine, in effetti, essendo da sole in grado di assorbire molte unità lavorative, penalizzano in grandissima misura la virtualità manuale e fattuale del singolo lavoratore.
In virtù e per gli effetti della legge economica, che regola il rapporto domanda-offerta, essendosi moltiplicata a dismisura la richiesta di lavoro, viene ridotto enormemente il salario, mentre si aumentano le ore di lavoro, nel quale vengono impiegati anche donne e bambini “carusi”.
Vige lo sfruttamento per opera della classe capitalistica e di quella borghese ed il proletario è sottoposto al peso insostenibile di un’immane fatica, che gli permette di condurre a stento una grama esistenza.
Tragica è la condizione in cui gli operai vivono in miniera.
Tale situazione è presente in Italia ed anche in Europa, come ci attesta Zola nella sua mirabile opera Germinal.
Pensatori e letterati del tempo riflettono sulla triste condizione del pauperismo, dello sfruttamento minorile.
L’intellettuale sente impellente l’esigenza di accostarsi al reale storico, di coglierne, oltre il vissuto, l’ideologia, per poi riproporlo nelle diversificate forme di pensiero e d’inventività espressiva nel campo artistico-letterario e in quello omnicomprensivo più ampiamente culturale.
Si delinea, in tal modo, una nuova lettura del reale con implicanze in tutte le componenti della conoscenza, da quelle socio-antropologiche a quelle proprie del vissuto esistenziale del popolo, espresso dai letterati del tempo con modalità tecnico-linguistiche ed estetiche del tutto innovative.
In questo modo il colloquio tra l’intellettuale ed il popolo diventa autentico. Denominatore comune ai pensatori, ai letterati e agli artisti del tempo è la concezione dell’umanismo del lavoro.
Teorizzatore del concetto dell’umanismo del lavoro è K.Marx.
Il pensatore, che concepisce la realtà come risultante dalle forze produttive del lavoro, enuclea la legge del plusvalore, che permette la capitalizzazione ingente di somme di denaro nelle mani di pochi, provocando un inarrestabile stato d’immiserimento nel proletariato.
Il capitale accumulato è per Marx, infatti, un rapporto sociale conflittuale ed antagonistico fondato sullo sfruttamento del lavoro.
L’analisi della società capitalistica, formulata da Marx, ingenera una nuova filosofia della storia.
Così scrive Marx (Marx- Prefazione a “Per la critica dell’economia politica” trad.it. di E. Cantimori-Mezzamonti- Roma –Ed. Riuniti pp. 10-12)
“Il cambiamento della base economica sconvolge tutta la gigantesca sovrastruttura. Quando si studiano simili sconvolgimenti è indispensabile distinguere sempre tra lo sconvolgimento materiale delle condizioni economiche della produzione che può essere costatato con la precisione delle scienze naturali e le forme giuridiche, politiche, religiose, artistiche e filosofiche, ossia le forme ideologiche che permettono all’uomo di concepire queste forme e di combatterle.”
La tesi, postulata da Marx, riguardante l’interrelazione tra lo studio delle scienze economiche e le scienze naturali, ci avvicina al discorso sulla fisica sociale, propugnato da Comte.
Invero sia per Marx come per Comte la sociologia deve essere intesa come scienza positiva.
Il compito della sociologia o fisica sociale è per Comte quello di rimuovere le teorie teologiche o metafisiche e di organizzare la società su basi scientifiche, fondate sull’esperienza della vita associata.
Partendo da questo presupposto Comte spiega l’evolversi della religione, dei costumi, delle leggi.
La questione sociale, per Comte come per Marx, costituisce la base fondante della storia in rapporto alla società, in generale, e all’uomo-individuo in particolare, che nel contesto sociale, intesse i fili della storia.
I due autori Marx e Comte, nonostante una certa comunanza di percezione del reale, in cui vivono, approdano a conclusioni diverse.
Marx è tutto calato nel concetto dell’umanisno del lavoro con attento sguardo alle forze produttive costituenti la struttura socio-economica del mondo, Comte, invece, del concetto della fisica sociale fa una vera religione, concependo la visione di un Grande Essere, non più riferibile a Dio, ma all’Umanità.
Il filosofo, inoltre, ritiene che si possa approdare ad una morale sociologica in cui l’egoismo è superato dall’altruismo.
Si parla, pertanto, di un positivismo utopistico, caro alla classe borghese, ma non tenuto in conto dagli intellettuali del tempo, che intendevano proporre un dialogo più autentico e reale col popolo. Osserviamo, infatti, come anche il Verga non si concede a qualsiasi forma di utopismo, ma piuttosto sempre più cerca di immedesimarsi e di rappresentare la plebe schiacciata dal piede brutale del progresso. Tuttavia è da considerare che la concezione positivistica di Comte ha influenzato la cultura moderna e ha indotto a porre l’attenzione sull’importanza conoscitiva del mondo attraverso un’indagine, rivolta in forma complementare, alle scienze umane, alla sociologia e alla psicologia.
Più incisiva appare nel panorama culturale la teoria dell’evoluzionismo di Spencer.
Per Spencer “compito della sociologia è quello di determinare le leggi dell’evoluzione super-organica, cioè le leggi che regolano il progresso dell’organismo sociale. In altri termini la sociologia è lo studio dell’ordine progressivo della società come un tutto”. (Principles of P Sociology 1876.1).
La sociologia di Spencer è orientata nettamente verso l’individualismo e, quindi, verso tutte le libertà individuali, in contrasto con la sociologia di Comte e, in generale, con l’indirizzo sociale del positivismo, giusta l’opinione dell’Abbagnano.
Queste premesse ci fanno capire come il pensiero di Spencer, orientato verso l’antropologia e lo psicologismo, abbia influenzato la formazione dell’intellettuale del tempo.
Spencer, infatti, attribuisce grande importanza alla psicologia, che ritiene nella sua natura ultima, irrinunciabile e che deve essere studiata in tutte le sue manifestazioni.
Sarà anche impegno degli intellettuali del tempo e, soprattutto dei romanzieri, quello di studiare e far rivivere nel romanzo il personaggio reale e non quello fictus, prerogativa dell’autore omnisciente.
Il romanziere è, invero, un autore scienziato, che si eclissa nel personaggio, di cui rivela il suo essere autentico attraverso tutte le manifestazioni della sua psiche e della sua esistenza umana, nel contesto sociale, in cui vive, secondo il canone teorizzato da Ippolito Taine e proposto nella triade race-milieu –moment.
Il Verga stesso dice che “l’opera d’arte deve apparire come fatta da sé”, nella quale non si sveli “il fiat del creatore”.
La creazione dei personaggi s’inserisce, a buon diritto nelle teorie contemplate dai pensatori del tempo ed assume forme estetico-contenutistico-culturali del tutto originali.
Nel momento, in cui il Verga si accosta alla Sicilia, l’autore opera la sua operazione culturale-artistica più significativa.
Non si tratta di aderire a forme di provincialismo o di regionalismo, come una miope critica ha tentato di congetturare, ma piuttosto di informarsi a quel concetto di ideologia del reale, che sarà poi sviluppato da Luckàcs, e che imprimerà all’arte verghiana una valenza artistica di portata europea, imparentandosi con Flaubert, Zola, Dickens.
Per accostarsi compiutamente all’ideologia del reale il Verga sente insopprimibile l’esigenza di ritornare alla Sicilia e di allontanarsi da Milano, in cui aveva maturato un’esperienza letteraria di tipo scapigliato.
La Sicilia, infatti, non deve essere considerata come un limite all’inventività artistica, ma come il nucleo germinante di tutta la vera ed autentica vita di letterato e di intellettuale del Verga, impegnato, per dirla alla maniera gramsciama, a riproporre tutto il reale (e quale reale per l’autore se non la Sicilia ed il suo popolo?) nei modi propri dell’arte.
Lo testimonia una lettera indirizzata al Capuana (Milano 13 marzo 1874).
“Quel Milano che tu ti sei immaginato sarà sempre inferiore alla realtà, non perché tu non abbia immaginazione tanto fervida da fantasticare una Babilonia più babilonia della vera. Ma perché ho provato su di me che non arriveremo mai ad accostarci alla realtà di certe piccole cose che ci fanno piccini alla loro volta, e ci danno forza da giganti. Io immagino te, venuto improvvisamente dalla quiete tranquilla della nostra Sicilia, a sentirci penetrare di tutta questa febbre violenta di vita in tutte le sue più ardenti manifestazioni, l’amore, l’arte, la soddisfazione del cuore, la misteriosa ebbrezza del lavoro, provenienti da tutte le parti, dall’attività degli altri, dalla pubblicità qualche volta clamorosa, pettegola, irosa, dagli occhi delle belle donne, di facili amori o delle attrattive pudiche.”
Leggendo questa lettera possiamo affermare che il Verga aveva ben chiaro il suo compito di letterato, impegnato a tradurre in parole tutto quanto il reale e ad esprimerne l’essenza più vera.
Vengono anticipati i termini con cui parlerà più innanzi Gramsci in “Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura”
“ Il modo di essere nuovo intellettuale non può più consistere nell’eloquenza, motrice esteriore e momentanea degli affetti e delle passioni, ma nel contempo mescolarsi alla vita pratica, come costruttore, organizzatore, “persuasore permanente”.
La letteratura deve condurre alla vita autentica e non a quella ideale, che spesso e, soprattutto nell’età idealistico-romantica, si rapportava agli intendimenti dell’autore più a colloquio con se stesso che non col popolo.
Un altro punto di contatto, tra la concezione dell’intellettuale gramsciano e le risultanze dell’estetica verghiana, adducenti al binomio letteratura-vita possiamo rinvenirlo nelle parole espresse da Gramsci in “Letteratura e vita nazionale”.
“ La premessa della nostra letteratura non può essere che non storica, politica, popolare: deve tendere ad elaborare ciò che esiste; polemicamente o in altro modo non importa, ciò che importa è che essa affondi le sue radici nell’humus della cultura popolare così com’è, con i suoi gusti, le sue tendenze, col suo mondo morale ed intellettuale, sia pure arretrato e convenzionale”. Abbiamo riportato questo brano di Gramsci perché ci sembra chiarificatore dell’argomentazione, che ci sforziamo di esporre “L’intellettuale “a colloquio” con il popolo nell’età postunitaria”.
Inoltre il richiamo di Gramsci ad una letteratura storica, politica, popolare non può che indurci a soffermarci sulla questione Meridionale, nel cui periodo Verga matura la sua esperienza di uomo e di letterato.
E’ lo stesso Gramsci, che ci avvicina al discorso sulla questione meridionale.
Gramsci, infatti, studiò profondamente il problema e rilevò, proprio con riguardo alla Sicilia, il divario tra classe operaia e classe agricola con tutte quelle implicanze di carattere socio- politiche connesse al tempo.
Possiamo considerare anticipatore dell’ideologia gramsciana il Verga, che, al pari delle Inchieste di Franchetti e Sonnino, nella sua opera letteraria ci testimonia la realtà socio-politica della Sicilia del tempo col preciso intento di realizzare, attraverso gli eventi e i personaggi rappresentati, un documento, che, oltre a radicarsi nella storia, contiene in sé tutte le caratteristiche
appartenenti alla sfera umana.
2
LA QUESTIONE MERIDIONALE
Dopo il 1860 l’unità politica non viene sorretta dall’unità socio-economica del paese e particolarmente nel Mezzogiorno ancora si delineava il divario città-campagna che per tanti secoli ha vessato la nostra storia.
Mentre il Settentrione si ergeva ad una struttura sociale evoluta ed industrializzata, il Mezzogiorno era ancora pietrificato in un arcaico passato.
Il Mezzogiorno, dice il Caizzi, “era figlio della sua straordinaria storia, intessuta quasi tutta di disgraziate vicende, di guerre intestine ed incursioni straniere.”
Il prezzo dell’unificazione, di cui parla il Procacci, fu soprattutto politico.
Il nuovo stato aveva come fulcro la fisionomia del Piemonte.
Infatti, sino al 1864, la capitale rimase Torino e l’assetto amministrativo veniva basato sulle autonomie delle regioni e sul decentramento, elaborate da Farina e Minghetti.
Anche la legge elettorale, estesa a tutto il paese, fu quella in vigore nel paese dopo il 1854, con il risultato che, dato il più basso grado di sviluppo economico della maggior parte delle altre regioni, ed in particolare del Mezzogiorno, il già ristretto sistema censitario ne risultò accentuato e il voto divenne in più di una regione il privilegio di pochi notabili.
Nelle elezioni del 1861, le prime della storia italiana, gli iscritti erano 167.000 nell’Italia settentrionale, 55.000 in quella centrale, 29.000 nell’Italia meridionale.
Lo stato italiano nasceva con una forte impronta burocratica.
Il divorzio tra governanti e governati, tra élite e massa popolare appariva evidente.
Nell’Italia meridionale la parte più derelitta esplode in una disperata forma di brigantaggio, che era altresì appoggiato da agenti borbonici, costituito nella maggior parte da contadini e da renitenti di leva.
Facendosi bandito il contadino non intendeva – e lo riconobbe l’inchiesta promossa dal Parlamento dal deputato Massari- esprimere il suo attaccamento al vecchio ordine di cose, quanto la sua avversione al nuovo, dare sfogo alla propria delusione e disperazione.
Sempre nel Mezzogiorno manifestazioni di collera popolare si ebbero anche nelle città, come la rivolta di Palermo del 1866, che fu repressa con l’invio di un corpo di spedizione.
La protesta della massa diveniva una costante nel panorama sociale e politico della nuova Italia, che lottava contro una politica prevalentemente fiscale e che millantava di ammantarsi di liberismo.
Nel Mezzogiorno, in particolare, l’ambigua commistione tra liberismo e fiscalismo produsse perniciose conseguenze nell’organismo sociale.
La politica della sinistra giovane, promossa da Agostino Depretis, già deputato della sinistra al parlamento subalpino e collaboratore di Garibaldi in Sicilia, non riesce a sanare il conflitto nord-sud.
La politica della sinistra, piuttosto, sembra rapportarsi al partito dei “galantuomini” e di larga parte della borghesia del Mezzogiorno.
La classe dirigente non si curava di riforme, di istruzione elementare obbligatoria; piuttosto traeva dal Mezzogiorno privilegi ed interessi economici.
L’avvento della sinistra al potere, invero, non perseguì quel radicale cambiamento di rotta, che i pochi avevano temuto e che i molti avevano sperato.
Il bilancio delle riforme, introdotte nei primi anni di governo della Sinistra, non può considerarsi del tutto efficiente.
La legge stessa, che prevedeva l’obbligatorietà dell’istruzione elementare da sei ai nove anni, (la precedente legge Casati del 1859 prevedeva soli due anni d’istruzione obbligatoria) venne disattesa.
L’abolizione della tassa del macinato, la riforma parziale dei codici ed infine la riforma elettorale per opera di una politica, che si denominò “trasformismo” favorì non il proletariato, ma i ceti borghesi ed i “galantuomini” del Mezzogiorno.
La riforma elettorale, promossa nel 1882, permise un ampio allargamento di partecipazione al voto.
Gli elettori salirono dal 500.000 a più di 2.000.000 milioni con una misura dal 2 al 7 per cento della popolazione.
Vale la pena dire che la riforma, basata sul censo, favoriva di gran lunga la città alla campagna.
Coloro, che perciò maggiormente beneficiarono del suffragio, furono la media e piccola borghesia.
Conseguentemente la politica meridionale rimaneva dominata dalle clientele e dai “galantuomini”.
Questa situazione crea situazioni penose, che, fino al giorno di oggi, sono la piaga della nostra società.
Le “ Lettere Meridionali”, raccolte in volumetti da Pasquale Villari, con fermo intendimento critico affrontavano temi ben definiti: il brigantaggio, la mafia siciliana, la camorra napoletana, fatti tutti che al Villari apparivano come “la conseguenza logica, naturale di un di un certo stato sociale, senza modificare il quale è impossibile sperare di poter distruggere questi mali”.
Brigantaggio, banditismo, mafia, violenza privata occupavano anche il primo posto nell’inchiesta del Franchetti, che scopriva nel malsano ed abominevole costume, manifestazioni profondamente connaturate ai meridionali con un sistema di vita, nel quale sopravviveva la prevalenza dell’autorità privata su quella sociale, ed il diritto continuava ad avere come unico criterio di giustificazione la forza anziché la legge.
Da qui la diffusione del male sociale della mafia, che si manifestava in atteggiamenti sconcertanti: l’omertà generalmente goduta dai malfattori, l’importanza determinata dalla violenza nei rapporti privati, le strette relazioni esistenti tra i ribaldi di mestiere e le classi agiate ed influenti della popolazione, la vita amministrativa, ridotta a contese di fazioni.
Ne deriva che il patrimonio pubblico era indirizzato a favore di pochi capaci di prevalere di volta in volta con la violenza.
Il volto della delinquenza mafiosa in collusione con gli interessi politici viene messa in chiara luce dal Franchetti, che dice “ognuno delle parti contendenti cerca di rafforzarsi estendendo le sue alleanze nella riserva inesauribile dei prepotenti, dei latitanti, dei malfattori, degli assassini”:
(Franchetti-Sonnino – La Sicilia nel 1876-pp. 10 sgg.)
La lentezza e l’onerosità della giustizia disarmavano le comunità più povere a richiedere la difesa dei propri diritti.
La grande confusione, esercitata dal governo nei poteri legislativi ed in quelli giuridico-istituzionali, facilitava la violazione della legge.
Sindaci e consiglieri, che avrebbero dovuto tutelare l’interessere, erano spesso usurpatori del diritto.
Donde il profondo risentimento dei contadini e le loro reazioni violente, l’occupazione delle terre a mano armata di terreni demaniali, gli incendi dolosi di boschi ed altri fatti di sangue ancor più gravi.
Ma invero questi accadimenti sono da considerare eventi sporadici, che non perseguono le finalità proposte. Anzi tutte le azioni promosse dai contadini venivano soppresse cruentamente. Al proletariato non rimaneva altro che soccombere senza talora poter pronunciare un grido di protesta.
Silenzio e desolata rassegnazione avvolgevano quella plebe, soggiogata dalle forze della politica, del progresso e talora anche dalle impervietà della natura stessa.
Esemplificativo al riguardo è il contenuto della novella Libertà del Verga.
Scrive Giustino Fortunato nel 1876 “A dir tutto le quotizzazioni, come furono prescritte dalle leggi, non hanno agevolato nell’Italia se non il monopolio dei terreni nelle mani dei proprietari; esse insieme con le nuove leggi di imposta accrescono di giorno in giorno le grandi proprietà a danno delle piccole”.
La storia del Mezzogiorno dell’Italia, dall’antichità in avanti, con le sue particolari vicende e le sue molte disgrazie e le tante disuguaglianze con la storia generale dell’Italia, sembrava al Fortunato inintelligibile, se non studiata prescindendo dalla geografia della penisola.
La geografia, insegnava anzitutto che il Mezzogiorno, osserva l’autore, era una regione nel complesso naturalmente infelice per la sua stessa configurazione longitudinale, piena di asperità e terre aride e lunghe prode malariche, per le troppo montagne e le valli abbandonate.
Nel percorrere le nostre province il Fortunato si sentiva pervadere da un senso indicibile di turbamento e di meraviglia, che lo induceva a credere ad un cataclisma, ad un’incursione dei barbari, all’accorata elegie di quelle “terre morte”, di quegli antichi paesi abbandonati dagli uomini, di cui parlano i cantori dell’Ellade e dell’Asia minore e concludeva “Voi pensate allora come a una lotta crudele fierissima tra l’uomo e la natura: una lotta in cui l’una e l’altra portano indelebili le tracce dolorose”. Non ci sentiamo di condividere l’opinione del Fortunato, che indulge, ad una forma di determinismo geografico-antropologico, senza spiegare le vere ragioni del paesaggio siciliano, non derivante precipuamente dal suo assetto geofisico, ma soprattutto devastato dall’incuria del malgoverno. L’accentuazione del Fortunato, riguardante una condizione preordinata dello status generale della Sicilia, ci appare destituita di veridicità storica.
Saranno, invece, gli autori quali Verga, Pirandello, Tomasi di Lampedusa, Vittorini, Quasimodo, che riusciranno nelle loro opere a raffigurare il vero volto della Sicilia. Il paesaggio siciliano è per i nostri autori la cifra poetica, in cui si snodano le vicissitudini del tempo in una descrittività, che è insieme momento drammatico,elegiaco e trasposizione del vissuto umano.
Agli occhi del popolo siciliano, se la terra appare desolata, questa condizione non è certo da attribuire agli elementi primordiali della natura, quanto al disinteresse di una classe politica, che, disconoscendo la fatica del contadino, abbandona le terre alla malaria e non si occupa di valorizzare quei beni inestimabili che il suolo siculo possiede.
Il paesaggio, allora, si fa tutt’uno con la tragicità dell’esistenza, della quale lo stesso diventa metafora,in accordo con le variegate e spesso discordanti situazioni ambientali, storiche, politiche.
Per gli autori del tempo, il paesaggio si fa storia viva e palpitante, in cui si compiono tutte le vicissitudini del genere umano nel tempo e, attraverso il vissuto personale, nella contestualità del gruppo sociale.
Per questo motivo in autori coevi la tonalità del paesaggio si colora di tinte del tutto diverse e talora contrapposte.
Riporto ad esemplificazione di questo assunto due brani letterari, il primo è tratto dall’incipit de I Vecchi e i Giovani di L.Pirandello, l’altro dall’explicit del Germinal di E. Zola.
Entrambi gli autori trattano nelle loro opere la delusione storica, che, alla fine dell’800 e, perdurando lungo tempo, lacera non solo l’Italia, ma tutta quanta l’Europa.
Sia Pirandello che Zola fanno rivivere nelle loro opere eventi susseguenti alla seconda metà dell’800.
Pirandello pubblica la sua opera nel 1913, ma ambienta l’azione del romanzo nel periodo delle prime lotte dei Fasci Siciliani (1893).
Zola pubblica Germinal nel 1885 e tratta un tema, presente peraltro in Verga e Pirandello, delle miniere, ed in particolare dei due scioperi attuati per opera dei minatori, a Ricamarie, nel dipartimento della Loira, il 16 giugno del 1869 ed il 7 ottobre del medesimo anno, ad Aubin, nel dipartimento dell’Aeyron.
Dall’incipit de “I vecchi e i giovani”
“ La pioggia, caduta a diluvio durante la notte aveva reso impraticabile quel lungo stradone di campagna, tutto a volte e risvolte, quasi in cerca di men faticose erte e di pendii meno ripidi………………………………………………
Piovigginava ancora a scosse nell’alba livida tra il vento che spirava gelido a raffiche di ponente; e a ogni raffica, su quel lembo di paese emergente or ora, appena cruccioso, dalle fosche ombre umide della notte tempestosa, pareva scorresse un brivido dalla città………………………Pioggia e vento parevano un’ostinata crudeltà del cielo sopra la desolazione di quelle piagge estreme della Sicilia, su la Girgenti nei resti miserevoli della sua antichissima vita raccolta lassù, si levava silenziosa ed attonita superstite nel vuoto di un tempo senza vicende, nell’abbandono d’una miseria senza riparo”.
Da “Germinal” di Zola explicit
“ Alto nel cielo, ora il sole di germinale raggiava in tutta la sua gloria. Al caldo
dei suoi raggi, la terra sprigionava in mille forme la vita dal suo grembo materno. Le gemme degli alberi si schiudevano in lucide foglie; i campi trasalivano sotto la spinta dell’erba, agognanti alla luce. Per la vegetazione in succhio, si propagava come un fremito: era la linfa che urgeva sotto le cortecce. Ma sotto quel tripudio della natura, sempre più distinto, il giovane (Stefano) continuava a udire l’oscuro travaglio dei minatori. E di questa messe la terra era incinta; una messe che spunterebbe un giorno alla luce, grandeggerebbe nei solchi per gli imminenti raccolti. Là in fondo era un esercito vendicatore, che schiantando la terra, ben presto esploderebbe alla luce”.
Nel brano pirandelliano i campi semantici connotanti il paesaggio sono pioggia-alba livida –elementi naturalistici che fanno da sfondo alla tragica visione di “un’ostinata crudeltà del cielo sopra quelle piagge estreme della Sicilia”. Il paesaggio, inoltre, ”cruccioso, dalle fosche ombre umide” enuclea il pessimismo pirandelliano, che tradito anche dalla lezione verghiana, nella natura rivela l’angoscia esistenziale del popolo siciliano.
Quella “desolazione”, che “si levava silenziosa ed attonita superstite nel vuoto senza vicende, nell’abbandono senza riparo” non è da considerare soltanto un’annotazione paesaggistica, ma un aspetto assiologico del romanzo in tutti i suoi aspetti di carattere estetico-culturale e socio-antropologico.
Il “vuoto” di un tempo senza riparo semantizza la reale condizione del popolo siciliano, che soccombe inerte all’iniquo potere delle forze allora dominanti, chiuso nel “silenzio” e nella muta rassegnazione.
Al tempo vuoto, infatti, Pirandello correla “l’abbandono di una vita senza riparo”.
Del tutto diverso è il paesaggio nell’explicit del Germinal di Zola.
L’autore, che pure nel suo romanzo aveva espresso con rara efficacia stilistico-espressiva la lotta dei minatori, di cui aveva rivelato, talora con crudo realismo tutti gli aspetti caratteriali con precisa connotazione psicologico- naturalistica, attraverso le vicende dagli stessi miseramente e dolorosamente vissute, conclude il suo romanzo con l’apparizione del sole (germinal).
Gli indicatori connotanti il paesaggio sono il sole di “germinale”, che “alto nel cielo raggiava in tutta la sua gloria”.
Il contrasto tra i due paesaggi evidenzia un cronotopo, in cui spazio e tempo coincidono con varietà di toni e di situazioni psicologico-esistenziali, riferibili al contrapposto modo di sentire dei personaggi e alle contraddizioni esistenti, nello stesso periodo, in ambiti regionali, nazionali e sopranazionali.
In quest’ottica possiamo comprendere la differenza profonda dei due paesaggi: in quello pirandelliano l’imperversare della pioggia in un’alba livida, in quello zoliano l’irradiarsi del sole che feconda le messi.
Il paesaggio diventa per entrambi gli autori figura stessa del tempo storico.
L’habitat naturalistico zoliano si schiude, con l’immagine del germinale, alle teorie, che gli ideali del socialismo avevano alimentato nella classe operaia francese e, che, invece non avevano trovato eco nella tragicità esistenziale del popolo siciliano, immerso in “un vuoto di un tempo senza vicende, nell’abbandono di una miseria senza riparo”, come abbiamo ricordato poc’anzi.
Invero il popolo siciliano si sente votato alla desolazione e alla sconfitta. Anche quando tenta di ribellarsi viene trucemente sconfitto, come ci documenta il Verga, nella già citata novella Libertà
Zola, invece, conclude il suo romanzo facendo procedere il protagonista Stefano verso la “luce” nel momento stesso in cui “le gemme si schiudevano in lucide foglie” e i “campi trasalivano sotto la spinta dell’erba agognanti alla luce”.
Pregne di valenze semantiche sono le parole innanzi enunciate- trasalivano- vale a dire che la natura partecipa con tutta l’ebbrezza possibile di un vitalismo, che per gli esseri umani si traduce nel riscatto e nella propensione ad una vita autentica, degna di essere vissuta nei termini che le stesse leggi della natura prescrivono.
Il participio presente, poi, ”agognanti” indica un transito da una condizione, che è quella miserevole, in cui si aggirano i personaggi, ad una forte e vibrante tensione emotiva, che li spinge con atto volontaristico verso la luce.
La luce può essere considerata un iponimo del sole ed è insieme l’ultima parola colla quale si conclude il romanzo, quasi per fissare un episema: luce come metafora di riscatto, libertà.
E questo assunto lo chiarisce lo stesso Zola quando ci presenta Stefano, che, mentre procede incontrando la luce, “ ascolta l’oscuro travaglio dei lavoratori”
Sembrerebbe, allora, che prendesse campo l’ossimoricità della vita: da una parte il sole che sorge nel mondo, dall’altra il buio esistenziale del travagliato vivere quotidiano.
Ma proprio nell’ultimo rigo del romanzo l’autore scrive: “ là in fondo un esercito vendicatore, che schiantando la terra presto esploderebbe alla luce”.
Una siffatta rappresentazione non poteva essere concepita né da Verga, né da Pirandello.
A Ciaula, personaggio pirandeliano non rimane altro dopo una giornata di immane fatica che “scoprire la luna” e l’evento, anche se carico di intensa emotività lirico-introspettiva, si esaurisce sul piano intimistico e non promette nessun riscatto sul piano esistenziale e sociale del caruso.
Ancora più drammatico è l’epilogo della vita di un altro “caruso” di matrice verghiana: Rosso Malpelo, che viene sepolto dalla cava, vittima di un ineluttabile destino.
Il discorso, fin ora esposto, potrebbe sembrare una digressione se non fosse sostanziato dalla veridicità degli eventi storici e dai movimenti, a questi correlati.
Nella convinzione che un discorso letterario, anche nel suo aspetto meramente estetico, debba confrontarsi parallelamente sul piano diacronico e su quello sincronico colla storicità, comprensiva di ogni moto di pensiero e sentimento, inglobanti la linfa e la radice stessa del vivere dell’uomo, ci accingiamo a trattare brevemente gli aspetti salienti del movimento della Prima Internazionale, che permeò di sé non solo l’Italia, ma tutta quanta l’Europa e che creò atteggiamenti di pensiero afferenti in modo decisivo nel campo della cultura e del progresso sociale con risvolti producenti nel mondo delle lettere e delle arti.
La Prima Internazionale è preceduta dall’insurrezione proclamata nel 1863 dalla Polonia contro il dominio russo.
Un anno dopo, il 28 settembre 1864 nacque la Prima Internazionale, cui aderirono l’Inghilterra e la Francia e numerosi esuli politici come italiani (vicini alle idee mazziniane e soprattutto provenienti dal nord) insieme a polacchi, svizzeri, tedeschi. La Sicilia, invece, rimaneva chiusa in un’opaca renitenza e piegata al suo destino in uno stato di assoluta arretratezza e, per dirla secondo il discernimento del Verga, “senza aura di scampo”.
Animatore del movimento è stato K. Marx, che già nel Manifesto del 1848 aveva invitato la classe operaia a “spezzare le proprie catene”.
La Prima Internazionale si diffuse in tutta l’Europa ed anche in Italia, sopratutto ad opera di Bakounin, in un primo tempo seguace del pensiero di Marx, ma poi distaccatosi, in quanto proponeva un’azione rivoluzionaria, mentre l’autore del Capitale auspicava l’emancipazione della plebe in un processo dialettico che portasse a compimento la coscienza di classe del mondo operaio.
Il messaggio bakouniano chiamava le plebi in genere e la classe lavoratrice, in specie, all’unione e alla lotta non solo per la conquista di immediate realizzazioni di carattere economico e professionali, ma soprattutto per l’instaurazione, sulle rovine del mondo capitalistico, di un innovativo ordine sociale ed economico definitivo.
Nel Mezzogiorno Baukounin insistette particolarmente su un punto assai sensibile: “ la terra fecondata dal lavoro e dal sudore della plebe doveva appartenere ad essa per diritto naturale”.
Ma, anche se il nostro abile e travolgente agitatore mostrò grande interesse per la Sicilia, le cui condizioni generali gli sembravano assimilabili a quella degli umiliati e offesi della Russia, il popolo siciliano, a differenza della Francia e delle altre nazioni, non si mostrò pronto alla riscossa.
Il popolo siciliano, in effetti, non si liberò dall’atavico assoggettamento e dall’imposizione del potere precostituito, sottoponendosi agli interessi dei “galantuomini” e, non riuscendo ad elevare la propria voce, si rinchiuse in un silenzio dolorante e privo di speranze e di attese.
Le enunciazioni, appena espresse, sono tendenti a chiarire le ragioni per le quali autori, quali Verga e Pirandello sono distanti da Zola.
Comprendiamo, inoltre, come sia in Verga che in Pirandello lo sguardo, rivolto alla Sicilia, si compenetra con viva e sentita partecipazione emotiva, oltre che ideale, nel dramma vissuto dalla propria gente, che viveva in istato di separatezza e di abbandono, anche all’interno della propria nazione, in cui sempre maggiormente si conclamava la dicotomia tra Nord e Sud.
Al fine di una maggiore puntualizzazione del divorzio tra Nord e Sud, divorzio, che peraltro, come abbiamo visto, produceva in Sicilia uno stato di arretratezza rispetto anche agli stati europei, desideriamo soffermarci brevemente sulle posizioni critiche di alcuni pensatori, che si sono interessati al fenomeno.
Sul finire del secolo XVIII Nitti pubblicò un’opera: Nord e Sud.
Il Nitti argomenta che, all’atto dell’unità di Italia, il Mezzogiorno possedeva la maggior parte del capitale monetario circolare esistente in Italia, esattamente il 65,7% e che avrebbe potuto realizzare queste ricchezze in modo da sviluppare armonicamente i settori della sua economia, se da parte dello Stato non si fosse attuato uno spietato “drenaggio” di tale denaro a favore del Nord.
Le nuove gravissime imposte, la compera dei beni demaniali ed ecclesiastici, l’unificazione del debito pubblico provocarono un vero dissanguamento dell’economia meridionale, resa ancora più grave dopo il 1887, quando il Mezzogiorno divenne il naturale mercato di consumo su cui si scaricavano i prodotti industriali dell’Italia settentrionale.
Il Nitti perviene a questa conclusione: “fra l’Italia del Nord e quella del Sud la differenza di condizioni economiche e sociali si era accentuata rispetto al 1860.”
Vi sono ora due Italie: una progredisce rapidamente ed entra nel circolo della civiltà industriale, l’altra si dibatte in strettezze crescenti. La tesi del Nitti, ricchissima di dati e assai pregevole, quale interpretazione della realtà economica, sottintendeva una visione politica, fondata sul presupposto che, mantenendo inalterati i rapporti tra le forze sociali del paese, si potesse giungere, estendendo nel Sud gli effetti dell’industrializzazione, ed intervenendo con un’opportuna politica di sgravi fiscali,ad un processo di unificazione.
Il processo di unificazione risultò, però, vano e le differenze tra Nord e Sud furono accentuate nel periodo dominato dal Giolitti, mediante una politica, che assunse una forte impronta burocratica e che sfavorì grandemente l’economia del Meridione.
Gaetano Salvemini usò l’espressione rimasta famosa “ministro della malavita” nei confronti del Giolitti, che non rifuggì in certe circostanze di ricorrere a pressioni di vario genere per fare eleggere nei collegi elettorali deputati favorevoli al governo.
L’Italia aveva raggiunto particolarmente nel Nord traguardi nel campo dello sviluppo economico e sociale, ma era ancora la nazione degli emigranti, dei contadini poveri, degli analfabeti.
Puntuale e convincente ci appare l’analisi condotta da Gramsci sulla questione meridionale.
Nell’interpretazione di Gramsci, che approfondisce questa tematica nei “Quaderni del Carcere, il nostro opina che il mancato Risorgimento era la causa prima del divario tra Nord e Sud anche perché i democratici non furono capaci di mobilitare, accanto a una parte della piccola borghesia e del proletario urbano, le masse contadine del Mezzogiorno.
Questa frattura fra masse popolari del Sud e classe dirigente borghese è per lo studioso, il vero nodo strutturale della questione meridionale.
3
GIOVANNI VERGA: Tra storicità e letterarietà.
Con Nedda il Verga matura la sua istanza verista, Scrive il Russo: “Da questo momento non avremo più romanzi o novelle,in cui il protagonista sia il centro fantastico dei suoi dolori e delle sue riflessioni, ma la sofferenza, che nei romanzi giovanili poteva attribuirsi a squilibrio degli individui, ora il triste equilibrio intrinseco del mondo stesso si avvia ad una rappresentazione della vita. E la lingua non è più la lingua di un uomo colto, ma la lingua dei protagonisti stessi”.
La lingua parlata, anzi, aggiunge il Russo, è “la cellula del linguaggio poetico dello scrittore”.
Lo scrittore, invero, avverte la realtà quotidiana e la descrive nella crudezza di forme artistiche e linguistiche.
Per il Russo l’impersonalità dello scrivere si identifica con l’impersonalità del destino umano.
Uno scrittore cristiano, come il Manzoni, può accompagnarci per tutto il racconto o con una parola di fede o può sollevarci nell’attesa della provvidenza divina, ma per il Verga, invece, l’uomo è condannato da un fatalismo opprimente.
Lo stesso sentimento di amore spesso nel personaggio verghiano deve fare i conti colla miseria e con eventi talora cruenti.
Nella Vita dei Campi, in cui l’amore è sentito come profondo dramma, tuttavia si esalta la religione della casa, della famiglia, dell’onestà, motivi, che saranno ripresi e sviluppati ne “I Malavoglia”.
La logica religiosa della famiglia e del travaglio quotidiano assorbono tutta l’opera del Verga.
Dice ancora il Russo :“Il tempio della religione familiare è la casa: Il focolare domestico è Il luogo sacro donde procedono tutte le lotte e le tristezze e ogni tragedia, nel racconto del Verga, è sempre tragedia familiare”.
Accanto al sentimento dell’amore e del focolare domestico si affianca nel Verga, congiuntamente al fascino di un’innata forza bruta, un altro motivo: quella straordinaria capacità sinfonica di tracciare e sottolineare la musica del paesaggio, del mare, del cielo e di tradurre la natura in sentimento umano.
Si deve, peraltro, osservare che il punto, da cui parte il Verga, consiste nella identificazione di una società reale, nel suo regionalismo, nella vita elementare delle masse, nel suo stesso linguaggio dialettale, che è da considerarsi l’unico linguaggio vivo rispetto ad una lingua letteraria morta, astratta, stantia.
La poetica del Verga si forma e si sviluppa contestualizzandosi alla crisi storica specifica della sua regione.
L’attenzione, volta dal Verga al reale storico, possiamo coglierla nella novella Fantasticheria.
La novella consiste in una specie di lunga lettera, in cui lo scrittore ricorda ad un’amica le due giornate trascorse insieme ad Aci-trezza, rievocando in particolare le impressioni suscitate dalla visione della vita e del carattere di certi personaggi di quello sparuto villaggio di pescatori nella costa orientale della Sicilia.
L’elemento valoriale di questa novella consiste soprattutto nel fatto che essa segna una svolta definitiva nella ricerca attenta ed appassionata, che lo scrittore fa, per delineare il contrasto tra il mondo altezzoso e colpevole del lusso e della città e il mondo sano e doloroso della provincia.
Si delinea, in tal senso, il fulcro dell’ispirazione verghiana preconizzante “I Malavoglia”.
Nella Prefazione a “L’amante di Gramigna”, inoltre, ribadisce il concetto dell’impersonalità dell’arte.
Riportiamo dalla Prefazione alcuni brani che ci chiariscono l’evolversi della maturazione artistica dell’autore.
“ Il semplice fatto umano farà pensare sempre; avrà l’efficacia dell’essere stato, delle lacrime vere, delle febbre e delle sensazioni, che sono passate per la carne……………………………………………Quando nel romanzo l’affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così completa, che il processo della creazione rimarrà un mistero, come lo svolgersi delle passioni umane, e l’armonia elle sue forme sarà così perfetta, la sincerità delle sua realtà così evidente, il suo modo e la sua ragione di essere così necessari, che la mano dell’artista rimarrà assolutamente invisibile, allora avrà l’impronta dell’avvenimento reale, l’opera d’arte sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed esser sorta spontanea, come in fatto naturale, senza serbar alcun punto di contatto col suo autore, alcuna macchia d’origine”.
Nel proporre la scrittura come “documento umano” il Verga si mostrava assai preciso nella formulazioni delle sue intenzioni estetiche, nelle quali era implicita una chiara posizione polemica nei confronti del dramma inventato, della letteratura sentimentale, della psicologia d’eccezione.
Proprio per questa posizione polemica l’arte del Verga si presentava nella cultura italiana con una forte spinta innovatrice e per un lungo periodo la critica si trovò impreparata o in posizione di pregiudiziale rifiuto.
Il Capuana fu il primo a seguire le tappe fondamentali della nuova arte del Verga; cominciò con l’indicare nel bozzetto Nedda del ’74 la rottura decisiva col vecchio mondo romantico per il Verga, e l’instaurazione di un nuovo filone per la narrativa italiana.
il “ritorno” del Verga alla Sicilia non era soltanto un itinerario della memoria, che ritrovava il tempo appena intravisto, ma felicemente nella Storia di una capinera, ma segnava la possibilità per la nuova narrativa italiana di uscire dall’idealismo di convenzione per calare, per dirla con il De Sanctis, l’ideale nel reale.
Recensendo, poi, nell’80 le Novelle “Vita dei Campi” il Capuana riuscì a precisare in senso nuovo e moderno il concetto di “forma” e di “stile” penetrando coraggiosamente nel nucleo centrale del problema e dimostrando di capire ciò che altri critici non avevano intuito.
Così si esprime l’illustre letterato: “quando dico forma, non intendo soltanto la frase, ma qualcosa di più elevato: la concezione, tutto l’organismo dell’opera d’arte, che funziona con la pienezza della vita, libera ed indipendente dalla personalità che la creò”.
Alla semplicità quasi nuda del linguaggio verghiano era, pertanto, da rapportare il nuovo concetto di forma.
Partendo da queste premesse il Capuana, con riguardo in particolare a “I Malavoglia” deduceva interessanti spunti di riflessione concernenti la tradizione letteraria e la contestualità storico-culturale.
Per la prima volta i personaggi manzoniani non sono traditi, ma piuttosto trasferiti in un nuovo reale storico, a differenza di quelle narrative di tanti piccoli manzoniani, che si erano allontanati dalla lezione della “storia” che il Manzoni aveva impresso nella sua opera.
Il Torraca apprezzò pure l’opera dl Verga e salutò i Malavoglia come “prova di vigore intellettuale, che aiutano al pari degli scritti di Franchetti e Sonnino, a farci conoscere le condizioni sociali della Sicilia”.
Il Torraca, citando le inchieste di Franchetti e Sonnino, poneva l’accento sull’adesione alla storicità, che, al centro della nuova arte verghiana, si connotava essenziale e sostanziale degli intendimenti estetici dell’autore.
La compresenza di elementi storico-sociali, confluenti all’opera verghiana, è oggetto di riflessione anche da parte del Sapegno, che definisce la componente veristica presente nell’opera dello scrittore siciliano come “la letteratura che meglio di tutte aderisce alla storia vitale, al “ritmo progressivo” della storia, quella che raccoglie la parte più positiva e feconda dell’eredità romantica per trasmetterla alle generazioni future”.
In effetti, dopo il Risorgimento, sotto la vernice della democrazia e della libertà, esisteva una struttura burocratica, incapace di sanare il conflitto tra Nord e Sud e, di conseguenza, la Sicilia era soffocata dalla miseria e dall’ignoranza.
Illuminanti per comprendere appieno questa condizione storico-culturali ci appaiono ancora le parole del Sapegno “ da noi il verismo doveva assumere quel colore specialissimo che lo contraddistingue nel quadro di un’esperienza europea: colore regionale ed epico, che naturalmente accompagnava la scoperta e l’illustrazione di un mondo pressoché vergine e ignoto, il mondo del meridione e delle isole, delle plebi contadine ed artigiane chiuse nella loro opaca renitenza alle forme e agli statuti della civiltà moderna, affioranti, per così dire dal buio di una civiltà arcaica e stranamente sopravvissuta dietro le barriere di una secolare solitudine”.
Il Sapegno esamina il problema della solitudine e del silenzio anche in forma socio-antropologica e lo rinviene nella constatazione di una diffusa mancata coscienza popolare del popolo siciliano, che non si sente pronto a lottare per la rivendicazione dei diritti umani
Compito dello scrittore è, allora, conclude il critico, quello di “interpretare e tradurre in parole il disperato silenzio di una moltitudine estranea e lontana”.
Le plebi meridionali, invero, sembravano immerse in un pessimismo vittimistico senza possibilità di riscatto e salvezza.
Nei termini di una critica di stampo marxista, indulgendo a precise forme di indagine storica con annotazioni socio-antropologiche, riprende il discorso sul Verga il Trombatore, che afferma: “gli esempi del naturalismo e la questione meridionale guidarono il Verga alla scoperta della sua terra, della Sicilia, non di una Sicilia mitica e leggendaria, ma di quella popolazione di derelitti………. Le problematiche storiche congiuntamente a quelle filosofiche spinsero l’autore non a glorificare il progresso, ma a capire il senso drammatico della lotta”.
L’autore non si volge all’“ idoleggiamento” e alla “celebrazione” dei trionfatori, ma si piega alla miseria dei vinti, travolti dalla “fiumana del progresso”.
La novella Libertà ci presenta in modo netto la lacerante condizione della plebe meridionale.
La novella racconta una sommossa contadina durante la spedizione dei Mille: una di quelle violente e cieche espressioni di rancore a lungo covate per le angherie patite. Il popolo, insorgendo contro i suoi oppressori, non persegue consapevolmente e coerentemente un suo obiettivo politico.
L’orgia di sangue si esaurisce da sé col calare delle tenebre; la furia sanguinaria non ha risparmiato neanche le donne e i bambini.
Il giorno dopo giungono i soldati di Bixio a fucilare sommariamente i più indiziati e a riportare l’“ordine” nel paese sconvolto.
Desolanti sono le parole di un carbonaro che aveva partecipato alla sommossa e che adesso viene condotto in galera. “Dove mi conducete? In galera? O perché? Non mi è toccato neppure un palmo di terra. Se avevano detto che c’era libertà”.
Queste parole sono da considerare non solo la conclusione della novella, ma l’epilogo di una drammatica condizione esistenziale di derelitti “senza aura di scampo”.
Le delusioni, le miserie, le speranze, le lacrime di un intero villaggio tramano la storia de “I Malavoglia” popolato da una plebe, che si dibatte in una vita misera ed angusta senza possibilità di redenzione.
In tutto il romanzo domina la costante dell’oppressione nei confronti del popolo, che giusta l’osservazione del Trombatore, è da reputare la “tonalità grave” di tutto quanto il romanzo.
E, se qualcuno tenta di staccarsi dalla miseria e dall’oppressione, soccombe, come avviene a “Ntoni de “ I Malavoglia”.
E se, qualcuno più astuto e più tenace riesce ad impadronirsi delle leggi economiche e a salire il rango dei dominatori, anche quella è una vittoria effimera, che si risolve in una più tragica sconfitta.
Ci riferiamo in particolare al personaggio mastro-don Gesualdo, che da umile manovale, qual era, giunge a competere con i pezzi più grossi del paese e quasi a dominarli. Tuttavia mastro-don Gesualdo è appena sopportato se non escluso dal mondo dei nobili e dei “galantuomini”.
E quando egli muore solo lontano dal paese, in una stanzetta del palazzo del genero, senza neppure il conforto dell’affetto della figlia, mastro-don Gesualdo,consapevole dell’assoluta vanità e del fallimento di tutta la sua opera, è un vinto ed intorno al suo cadavere si esercita il chiacchierio pettegolo ed impudente della servitù.
Questo romanzo, osserva il Trombatore, “contiene la più alta protesta del Verga, il fremito più vasto della sua sorda e soffocata indignazione”
La rappresentazione di tutta quanta la realtà e il suo svelarsi nelle variegate forme delle classi sociali è senz’altro il principio fondante dell’estetica verghiana.
Ce lo spiega il Verga stesso nella lettera indirizzata all’amico Salvatore Paola il 21 aprile 1878.
“Ho in mente un lavoro che mi sembra bello e grande. Una specie di fantasmagoria della lotta della vita, che si estende dal cenciaolo al ministro e all’artista ed assume tutte le forme, dall’ambizione all’avidità di guadagno e si presta a mille rappresentazioni del grottesco umano, lotta provvidenziale che guida l’umanità attraverso tutti gli appetiti alti e bassi, alla conquista della verità.
Insomma cogliere il lato comico o drammatico di tutte le fisionomie sociali, ognuna colla sua caratteristica negli sforzi, che fanno per andare avanti in mezzo a questa onda immensa, che è spinta dai bisogni più volgari o dall’avidità della scienza di andare avanti, incessantemente, pena la caduta e la vita per i deboli e i maldestri.
Ciascun romanzo avrà una fisionomia speciale, resa con mezzi adatti. Il realismo,io,l’intendo così, come la schietta ed evidente manifestazione e l’osservazione coscienziosa, la sincerità dell’arte in una parola : potrà rendere un lato della fisionomia italiana moderna,a partire dalle classi infime,dove la lotta è limitata al pane quotidiano, come nel Padron ‘Ntoni, e a finire nelle varie aspirazioni, nelle ideali avidità di lusso, passando dalle avidità basse alle vanita di mastro-don Gesualdo, rappresentante della vita di provincia all’ambizione di un deputato”.
La precipua attenzione, protesa dal Verga nei confronti del realismo, nei termini e modi suesposti, porta alle estreme conseguenze il pensiero già espresso da Hegel, che concepiva il romanzo come un genere letterario nuovo, che si addice al mondo moderno, potendo accogliere in sé “la prosa della vita reale”.
Inoltre il nostro autore recepisce la lezione di Balzac, che, oltre ad avere ravvicinato la letteratura alla vita reale, studia approfonditamente le ragioni della sua tecnica narrativa finalizzate all’accostamento ai problemi dell’ideologia con quelli dello stile.
Invero sia la commedia umana di Balzac che tutto quanto il mondo verghiano, seguendo l’interpretazione di Lukàcs, possono esseri letti, oltre che come trasposizione dell’ideologia del reale nella pagina scritta, come grande universo linguistico.
La ragione linguistica diventa intrinseca alla logica stessa compositiva e strutturale dei romanzi con efficacia d’innovative tecniche sperimentali.
A proposito delle nuove tecniche, raccordabili soprattutto al romanzo sperimentale, non possiamo non ricordare quanto dice Zola “Il mio scopo non è quello di costatare dei risultati acquisiti, decido solo di esporre con chiarezza un metodo. Se il romanziere cammina ancora a tentoni entro la scienza più oscura e più complessa, ciò non toglie che questa scienza esista.
E’ innegabile che il romanzo, quale noi l’intendiamo, è un vero esperimento che lo scienziato compie nell’uomo con l’aiuto dell’osservazione (E.Zola- Il romanzo sperimentale-tard.it di I.Zaffagnini-Parma-Pratiche- 1980-pag 8)
Soffermiamoci brevemente ad analizzare la frase compresa nel brano zoliano, riguardo al romanzo “vero esperimento che lo scienziato compie nell’uomo e con l’esperienza dell’uomo”.
La fondamentale esigenza, invero, dell’intellettuale del tempo è quella di comprendere tutto l’universo umano e di riproporlo, come già abbiamo ricordato, nei modi propri dell’arte, secondo la formula, che Gramsci propugnerà qualche tempo dopo.
Un’altra parola-chiave è “osservazione”.
Questo principio lo troviamo anche in Verga nella Prefazione a“I Malavoglia”.
“…… ……..Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile per raggiungere la conquista del progresso è grandioso nel suo risultato, visto nell’insieme da lontano. Nella luce gloriosa che l’accompagna dileguansi le irrequietudini, le avidità, l’egoismo, tutte le passioni, tutti i vizi che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano l’immane lavoro, tutte le contraddizioni, dal cui attrito sviluppasi la luce della verità”.
Le parole del Verga ci esprimono chiaramente la sua posizione nei confronti della fiumana del progresso. L’autore manifesta un certo stupore ed una certa simpatia umana per i protagonisti del “cammino, incessante, febbrile” intenti a raggiungere “la conquista del progresso, ma questo progresso, secondo il giudizio del narratore, può essere considerato “grandioso solo se visto da lontano”.
Con questa affermazione il Verga prende le distanze dalla mitologia del progresso, celebrata in quegli anni e invece tende a sottolinearne gli aspetti negativi: “irrequietudini”, “avidità”, ”vizi”, “contraddizioni”, che connotano la fisionomia socio-antropologica del paese in quel periodo.
Lo sguardo dell’autore è rivolto ai vinti. La sua ideologia lo porta a scrutare il reale con l’osservanza schietta ed appassionata ed al contempo lo spinge a comprendere appieno il suo ruolo di intellettuale.
“Solo l’osservatore, travolto anch’esso dalla fiumana, guardandosi attorno, ha il diritto di interessarsi ai deboli, che restano per via, ai fiacchi che si lasciano sorpassare dall’onda per finire più presto, ai vinti che levano le braccia disperate, e piegano il capo sotto il piede brutale dei sopravvegnenti, i vincitori di oggi anch’essi avidi di arrivare, e che saranno sorpassati domani”
Nella parte finale della Prefazione Verga ci testimonia i principi fondamentali della sua arte: la sua osservazione schietta e sincera del reale, la sua poetica dell’impersonalità e la tecnica narrativa della regressione.
Il realismo verghiano, peraltro, espresso nella ricordata lettera al Paola, assume, altresì come nello Zola e negli autori rappresentativi del periodo, una specifica connotazione ideologica.
Da qui la grande valenza del romanzo del periodo, oggetto della nostra trattazione, sino ai nostri giorni, e la sua specifica intenzionalità nel legare uno stretto rapporto tra letteratura-vita ed intellettuale-pubblico.
Le denunce, contenute in tutta la vasta attività narrativa verghiana e degli autori coevi, sono da considerare, giusta l’affermazione del Cesarani, “un’allegoria del mondo disumano nell’ottica degli egoismi padronali e della borghesia capitalistica”.
I personaggi dei romanzi del tempo non sono ideali, ma piuttosto “figure” dell’ideologia del reale, osservata e vissuta dagli autori.
E se ogni personaggio è simbolo, oltre che dell’ideologia, del vissuto dell’autore, ci spieghiamo la profonda differenza tra Stefano, protagonista del Germinal di Zola e Rosso Malpelo del Verga.
Stefano e Rosso vivono entrambi la tragica realtà delle miniere, ma mentre Stefano, come abbiamo visto precedentemente, potrà incamminarsi verso una luce redentrice, emblema di un possibile riscatto, Rosso è vittima sacrificale della lacerante situazione storica, in cui versa la Sicilia.
Rosso Malpelo finisce per acquistare una dimensione protagonistica ed eroica da eroe maledetto.
Come osserva il Baldi “ l’ingresso del punto di vista di Rosso in quel mondo dominato da una legge ferrea, in cui la coscienza non è che riflesso meccanico e accettazione positiva della realtà di fatto, ed in cui il soggetto aderisce senza margine di distacco ad un’oggettività oppressiva e si annulla in esse, apre lo spiraglio della coscienza attiva e del giudizio in opposizione all’ottusità e all’indifferenza, che è tipica dell’ambito, che lo circonda, l’eroe, sotto la spinta dei suoi sentimenti filiali offesi, della sua rabbia di sfruttato e del suo odio di classe per gli sfruttatori giunge a vedere il vero volto di quella società antagonistica fondata sulla violenza e sull’oppressione”. (G.Baldi- Rosso Malpelo in “L’artificio della repressione-tecnica narrativa e ideologica del Verga-Liguori-1980 pp.47-48).
Le due figure, messe in contrapposizione, potrebbero indurci, come è avvenuto per il passato, secondo i paludamenti di stereotipi critici, a considerare il mondo della poetica zoliana estraneo a quello verghiano.
Donde tutti gli accademismi, accentuati da molti “ismi”: regionalismi, provincialismi, naturalismi e quanto altro.
Invero Verga come Zola, e tutti gli altri autori rappresentativi del tempo, seguivano la logica dell’ideologia del reale, sorta dall’osservazione diretta dei fatti e dei personaggi, resi vivi nella loro autenticità attraverso la scrittura, mediante appropriati strumenti stilistico-estetici.
Questa è la più grande lezione del realismo, tuttora presente, e dalla quale la nostra generazione trae insegnamento.
CAPITOLO SECONDO
La “parola” del Verga tra cinema, musica, arte pittorica.
1) Verga e il cinema
2) Dalla novella del Verga “Cavalleria Rusticana”all’omonima opera di P.Mascagni- La “Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni e “I Pagliacci” di R. Leoncavallo: un testo unico per la comprensione della musica verista in Italia.
3) Il realismo nell’arte pittorica: G. Courbet- G. Pellizza da Volpeda.
1
VERGA E IL CINEMA NEL ‘900.
Nel ‘900 un gruppo di giovani, che partecipavano alla rivista “Cinema”, diretta da Vittorio Mussolini, elaborano un progetto teorico e pratico per un’innovativa concezione del cinema italiano.
Si tratta di intraprendere la strada del realismo che in Italia trova in Verga il suo rappresentante più significativo.
Ha origine nel cinema la cosiddetta corrente del neorealismo, che non soltanto tendeva legare il cinema alla letteratura, ma anche a tutte le altre arti dalla pittura alla musica.
Luchino Visconti, che si era inserito nella Rivista Cinema, elabora un progetto preciso di trascrizione cinematografica de “I Malavoglia” di Verga.
Aderire al realismo nel cinema voleva significare altresì l’abbandono di tutti quei contenuti borghesi, che, nella letteratura come nel cinema, avevano creato una “falsa coscienza”. Nella rappresentazione dei personaggi verghiani, in un habitat nudo e crudo e, al contempo vergine e mitico, il nuovo cinema non intendeva, però, sottoporsi ad una realtà statica.
Attraverso la “lettura del reale” invece i promotori e L.Visconti, in specie, della nuova corrente, traevano linfa per la realizzazione di una tipologia di film-documento, espressione autentica di verità.
Il film-documento assume,inoltre, una valenza altamente sociologica e contribuisce ad inverare un processo culturale, che, come testimonia lo stesso L.Visconti, ci riconduce a Gramsci.
Così si esprime il regista:
“Interessato come sono ai motivi profondi, che rendono inquieta, ansiosa l’esistenza degli Italiani, ho sempre visto nella questione meridionale una delle fonti principali…….La sola letteratura narrativa, nella quale, nel quadro del romanzo italiano, sentivo di potermi accostare, dopo le letture giovanili, al momento in cui col primo film, sia pure con i limiti del fascismo, un tema contemporaneo della vita italiana, era quello di Mastro-don Gesualdo e dei Malavoglia. Poi venne la guerra, con la guerra la Resistenza, e con la Resistenza la scoperta per un intellettuale della mia formazione, di tutti i problemi italiani, come i problemi di struttura sociale oltre che d’orientamento culturale”
Le parole di L.Visconti sono significative per delinearci il dibattito culturale occorso nel decennio anni 40-50 del Novecento.
Ricordiamo, infatti, che data anno 1941 la prima edizione di Conversazioni in Sicilia di E.Vittorini, mentre il 1948 registra l’anno della comparsa La terra trema di L.Visconti, ispirato per l’appunto a “I Malavoglia” del Verga.
La lezione verghiana si riproponeva in quegli anni dopo l’oscurantismo culturale, prodotto dall’avvento del fascismo.
Si sentiva il bisogno di guardare la realtà e l’universo umano tutto quanto, ivi comprese le connotazioni psicologiche ed individuali del personaggio, e di tradurli nella scrittura filmica, nei termini e nei modi della narrativa verghiana. La lingua del Verga diventa la stessa lingua del cinema.
Il film-documento, inoltre, non si esaurisce in un’azione narrativa, ma, come afferma lo stesso Visconti, invita lo spettatore al ragionamento.
Sembra proprio che, dopo il ventennio fascista, prendano corpo in tutte le produzioni artistiche dalla narrativa, alla pittura, al cinema le parole di G.Verga, espresse nella prefazione della sua ultima opera “Dal tuo al mio” (1903)
“ Al lettore non sfuggono, come non sfuggono al testimonio delle scene della vita, il senso recondito, le sfumature di detti e di frasi, i sottintesi che lumeggiano tante cose con la pagina scritta, come la lagrima amara o il grido disperato, suonano nella fredda parola di questa verità e sincerità artistica quale deve essere perché così è la vita, che non si svolge, ahimè, in belle scene e teatri e eloquenti”.
Le parole del Verga preludono alla rivoluzione del cinema italiano del dopoguerra.
Il monito verghiano: l’autenticità delle scene, ispirate alla realtà, la lagrima vera, il metodo di verità e sincerità artistica, che ingloba tutta la vita, quale essa è, nel cinema neorealistico, sono i nuclei fondanti del discorso, che registi da Visconti a Rossellini a De Sica, intendono intrattenere col pubblico.
Le sequenze del film diventano una lingua ed una scrittura, che seguono gli stessi stilemi verghiani.
A buon diritto così il nuovo cinema s’inserisce nel dibattito culturale intellettuale-popolo, che a quel tempo viene teorizzato da Gramsci. Che la lezione di Gramsci fosse oggetto di peculiare attenzione per L.Visconti, per la costruzione di nuove forme di rese artistico-interpretative nel mondo del cinema, lo testimonia lo stesso regista, che dice:
“La chiave mitica in cui avevo gustato Verga non mi fu sufficiente. Sentii impellente il bisogno di scoprire fossero le basi storiche, economiche e sociali, nelle quali era cresciuto il dramma meridionale e fu la lettura illuminante di Gramsci che mi ha consentito il possesso di una verità che attende ancora di essere affrontata e risolta”.
L. Visconti spiega, nel prosieguo del suo discorso, la ragione per la quale la lettura di Gramsci era stata illuminante.
Il regista afferma che “non era stato soltanto impressionato dall’acutezza dell’indagine storica, condotta dal pensatore, ma soprattutto dalle indicazioni pratiche e realistiche in questa contenute.” Ricordiamo, infatti, ancora che Gramsci, a differenza di altri meridionalisti, aveva auspicato l’alleanza tra i contadini del Sud e la classe operaia del Nord, per il perseguimento della reale unità d’Italia, in tutti quanti gli ambiti, da quello storico a quello socio-ecomico e culturale. La riflessione, promossa da Gramsci nell’ambito storico, con particolare riferimento alla questione meridionale, è coincidente con l’assunto concettuale, dallo stesso enunciato e concernente la funzione dell’intellettuale.
La lezione gramsciana viene accolta con entusiasmo dai letterati e dagli artisti del tempo, tra i quali vi è L. Visconti, che dice:
“M’illuminò, inoltre Gramsci, sulla funzione particolare, insostituibile degli intellettuali meridionali per la causa del progresso, una volta che fosse stati capaci di sottrarsi al servilismo del feudo e al mito della burocrazia italiana”.
La Sicilia si presenta così come una metafora della vita della plebe sempre intenta ad un continuo e talora vano lottare.
Agli occhi di Visconti, come di Vittorini e di Quasimodo la Sicilia diventa emblema della storia dell’uomo, delle sue vicende umane, costituite da conflitti e da antagonismi, che creano un dramma essenzialmente psicologico, che ci rimanda al mondo verghiano.
Giovanni Verga, invero, non aveva soltanto creato un grande mondo poetico degli umili, ma aveva fatto rivivere un tempo e una società, affioranti da un’arte autenticamente realistica e al contempo creatrice di verità.
La Sicilia omerica e leggendaria de “I Malavoglia”, di “Mastro-don Gesualdo”,
de “L’amante di Gramigna” non poteva se non essere, conseguentemente, la matrice di ispirazione di un cinema, che, precedentemente mortificato da un gusto borghese e, talora fatuo e pieno di vacua retorica nell’età fascista, trovava il suo riscatto in una produzione artistica, che aveva l’intento di proporre nello schermo, con schiettezza e sincerità di toni, la rappresentazione di un’umanità che soffre e spera.
2
Dalla novella del Verga “Cavalleria Rusticana” all’omonima opera lirica di Pietro Mascagni. La “Cavalleria Rusticana” e “I Pagliacci” di R.Leoncavallo: un testo unico per la comprensione del filone della musica verista in Italia.
Il mondo della grande opera lirica, dalla fine dell’800 agli inizi del ‘900 sente l’esigenza di adattare la lingua musicale a quella dei narratori veristi.
Possiamo considerare l’origine del verismo musicale con la Traviata di Verdi e assai più tardi con la Carmen di Bizet.
I musicisti del tempo pongono alla ribalta del palcoscenico personaggi reali e non più ideali, cari al pubblico borghese di buona parte dell’‘800.
Una vera e propria rivoluzione nel mondo del melodramma è rappresentata dalla Cavalleria Rusticana, musicata da Pietro Mascagni, – (Livorno, 1863-Roma, 1945) – tratta dall’omonima novella del Verga ed adattata su un libretto scritto da Giovanni Torgioni-Tozzetti e Guido Menasci.
Fu rappresentata la prima volta il 17 maggio del 1890 al teatro Costanza di Roma e fu un successo enorme.
Nel 1888 l’editore milanese Edoardo Sonzogno annunciò un concorso, aperto a tutti i giovani musicisti, che non avevano scritto ancora un’opera.
Secondo le direttive del concorso l’opera doveva essere costituita da un atto unico.
Al concorso parteciparono Nicola Spinelli con l’opera Labilia, Vincenzo Ferroni con l’opera Rudello e Pietro Mascagni con la Cavalleria Rusticana, che vinse il concorso.
Dopo la prima rappresentazione della Cavalleria Rusticana il successo si diffuse in forma strepitosa in tutta Italia ed anche all’estero.
Grande fu l’ovazione che accolse l’opera in America, a Filadelphia al Grand
Opera House il 9 settembre 1891 e poi a Cicago il 30 settembre dello stesso anno.
Trionfale fu pure il debutto dell’opera il 30 dicembre del medesimo anno al Metropolitan Opera. In quell’occasione l’opera, che normalmente veniva eseguita assieme ad un’altra opera del compositore Zanetto, precede un frammento dell’Orfeo ed Euridice di Gluck. Da allora innumerevoli sono state e continuano ad essere le rappresentazioni dell’opera in Italia ed in tutto il mondo e sempre con caloroso successo di pubblico e di critica.
Nel 1892, intanto, un altro musicista, ispirandosi a Mascagni, Ruggero Leoncavallo – (Napoli, 1857-Montecatini 1919) – scrive una nuova opera “ I Pagliacci”, che racconta una storia realmente accaduta.
L’opera fu rappresentata per la prima volta il 21 maggio del 1892 al teatro Dal Verme di Milano, sotto la direzione del maestro Arturo Toscanini.
La sua aria più nota “Vesti la giubba”, cantata da Enrico Caruso, fu il primo disco al mondo a toccare un milione di copie di vendite.Il libretto è stato scritto dallo stesso Leoncavallo ed è desunto da un processo istruito dal padre magistrato. I Pagliacci, pertanto, si presentano non come un’opera, che non attinge al verosimile, ma al vero, in perfetta concordanza con le teorie e le istanze estetiche del verismo al tempo dominanti. Sia la Cavalleria Rusticana di P.Mascagni sia “I Pagliacci” di. R Leoncavallo hanno analogia di contenuti, ambientazione, effetti scenico-musicali. Entrambe le opere hanno come sfondo il Meridione; la prima si svolge in un paese della Sicilia, l’altra in un paese della Calabria. La cadenza temporale è ben determinata in entrambe le opere: nella Cavalleria Rusticana l’azione si svolge il giorno di Pasqua, né “I Pagliacci” durante la festa di Ferragosto..
La coralità delle feste paesane, costituita dal pullulare di personaggi genuini ed istintivi, è nelle due opere non solo un aspetto contornuale, ma una componente essenziale connotante le peculiarità del filone dell’opera musicale verista, di cui P. Mascagni e da R.Leoncavallo sono i più significativi rappresentanti.
Sorprendente è, inoltre, l’analogia di eventi e vicende, narrati nelle due opere, l’una tratta dall’opera verghiana, l’altra, dedotta dalla vita reale. Accomuna le opere il tema dominante della passione amorosa e della gelosia. Nella Cavalleria Rusticana si parla dell’amore indomito di Turiddu nei confronti di Lola, che era andata sposa a compare Alfio, quando il giovane era partito per assolvere gli obblighi di leva. Accanto alle figure di Turiddu, Lola, compare Alfio, vivono palpitanti e traboccanti di sentimento altri personaggi: la madre di Turiddu, mamma Lucia e la sua promessa sposa Santuzza.
L’opera si conclude con un grido corale disperato “Hanno ammazzato compare Turiddu”. Compare Alfio, spinto dall’irrefrenabile sentimento della gelosia, scontrandosi in un duello rusticano con Turiddu, lo uccide.
E’ presente nell’opera la concezione la concezione verghiana dell’amore-passione violenta che si conclude colla tragedia.
Già all’inizio dell’opera l’aria, cantata da Turiddu, denominata “La Siciliana”, a sipario calato, modulata con un ritmo del tutto nuovo, concitato e suggestivo, anticipava la costruzione di un mondo di passioni infuocate, dove vicenda drammatica e musica si fondevano insieme.
E’ da sottolineare che è la prima ed unica volta che un’opera contiene una romanza scritta in lingua siciliana.
Segno questo che Mascagni, sull’orma del Verga, per esprimere l’autenticità dello stato d’animo del suo personaggio, lo fa parlare con la sua lingua natia, realizzando quella sintesi perfetta, già postulata dall’estetica verista tra atto linguistico e forma artistico-poetica. Anche gli stilemi della lingua musicale di Mascagni sembrano, peraltro, conformarsi a questo principio.
Riportiamo il testo della Siciliana
O Lola ch’hai di latti la cammina
sì bianca e russa comu la cirasa
quannu t’affacci fai la vucca a risu
biatu cu ti dà lu primu vasu
‘ntra la porta lu sangu è sparsu
e nun importa si ci moru accisu
e s’iddu moru e vaiu ‘mparadisu
si nun c’attrovu a tia mancu ci trasu
Traduzione
O Lola che hai la camicia sporca di latte
sei bianca e rossa come l’albero di ciliegio
quando ti affacci sorridi
beato chi ti dà il primo bacio
dentro casa tua è stato sparso il sangue
e non m’importa se anch’io muoio ucciso
e se capita che muoia e vada in paradiso
se non ci trovo te non c’entro nemmeno
La romanza, che in primo momento, ad uno sguardo superficiale, potrebbe evocare gli antichi schemi della poesia d’amore siciliana e quelli della corrente stilnovistica, inneggianti ad un amore assoluto, che si eleva sino alle sfere del Paradiso, invero, ha delle connotazioni del tutto nuove ed intrise di umana, infuocata, drammatica sofferenza.
Lo notiamo attraverso la decifrazione dei segni linguistici.
Se nella scuola poetica siciliana ed in quella stilnovistica il rapporto analogico tra la donna e la natura è la “rosa” o il “giglio” e la sua apparizione si illuminava solo con un sorriso, che induceva alla contemplazione e alla trascendenza, del tutto differenti, più realistici e più carnali, oseremo dire, sono i segni linguistici che sottolineano l’imperversare dei sentimenti del cantore d’amore della Siciliana.
Lola è raffigurata “bianca e russa come una cirasa”. Gli aspetti cromatici aggettivali “bianca e russa” possono essere considerati come simboli del candore del sentimento puro (bianco), riferibile all’animo genuino ed istintivo del siciliano, mentre il rosso è indice di una passione tumultuosa e prelude al sangue che sarà profuso innanzi. Anche la “cirasa” ha una significazione del tutto realistica e terrestre.
La passione, che sconvolge e domina, fa credere a Turiddu che “biatu” è chi dà “ lu primu vasu” all’amata, anche se “lu vasu” preconizza il dramma che sta per compiersi.
Rosso-sangue sono gli ipersegni della vicenda drammatica, annunciata dal canto espresso in lingua siciliana e scandito da un incalzante ritmo musicale.
La tragedia, invero, è preannunziata dall’aria “La Siciliana” e Mascagni abilmente armonizza gli stilemi musicali alla drammaticità della vicenda.
Osserva Mario Morini in “I Cento anni di “Cavalleria rusticana”:
“Con Cavalleria Rusticana Mascagni aveva squarciato le quinte di cartone e i velari di velluto trasferendo in piazza i suoi sentimenti, le sue passioni: un’autentica piazza siciliana, dove la vita del paese si annoda, gioia e dolore di ogni giorno, scatto ed ineluttabile fatalità”.
L’ineluttabile fatalità, incombente nei personaggi verghiani, ed ora trascritti nelle note musicali di Mascagni, ha fatto dire a Henry Hedward Krehbiel:
“ La Cavalleria rusticana sembra pressoché classica, ha la terribile ferocia di una tragedia greca, ma anche la dignità, che la tragedia greca non ha mai violato”.
Che la Cavalleria Rusticana fosse trasposizione in scena della tragicità di eventi della vita reale, che si ripetono nel tempo, certamente lo ha intuito Francis Ford Coppola, autore dell’opera cinematografica “Il Padrino”.
Il regista, infatti, nel terzo capitolo de “ Il Padrino” propone nella colonna molti brani della Cavalleria Rusticana, opera, che recita, peraltro, il figlio di don Corleone, nel suo debutto, come tenore proprio nella parte di Turiddu al Teatro Massimo di Palermo.
Proprio durante lo svolgimento dell’opera avviene la strage nella quale vengono coinvolti diversi criminali e, all’uscita del teatro, persino la figlia di Michael
Quale maggiore efficacia espressivo-rappresentativa poteva essere attribuita ad un melodramma rivisitato simultaneamente all’evolversi di un evento reale e cruento, cui la stessa lingua musicale del Mascagni si accorda con il modulare di una tonalità lirica, che evocata dal dramma dalla vita reale, è tutta vibrante di quel tumultuoso pathos, che comprende e sottolinea le urla strazianti che il catastrofico evento produce?
Opportunamente il Morini aveva osservato che nella Cavalleria Rusticana “una forte sensualità e un temperamento passionale arroventano l’opera, che dall’inizio alla fine avvince ed emoziona; Mascagni aveva ereditato da Verdi il gusto della musica che scuote il sangue”
Ma nella rappresentazione filmica di Coppola il sangue scorre realmente e copiosamente e le note musicali di Mascagni si adattano ad interpretare la drammatica sequenza, rappresentata dal racconto filmico. Gli stilemi musicali, invero, della Cavalleria Rusticana imprimono la voce vera e dolente del reale, scandita fra trasalimenti dell’animo, angosce e consapevolezza della drammaticità esistenziale. L’orchestrazione di questi codici linguistici musicali, esaltando i moti dell’animo, stigmatizza la forza drammatica degli eventi, in un modulare di un declamatorio lirico, che evoca grida, lamenti, singhiozzi, pianti, che si perpetrano nell’avvicendarsi delle vicissitudini umane. Nel voler rappresentare in un’azione scenica simultaneamente, inoltre, il movimento musicale con l’evento reale, è presumibile che il regista abbia voluto realizzare col linguaggio cinematografico l’assunto categoriale del principio teatro-rappresentazione-verità, seguendo l’insegnamento di Pirandello, secondo il quale “l’arte è prioritaria alla vita”.
Se l’arte, poi, è prioritaria e, se soltanto l’arte ci può svelare la verità, si può comprendere facilmente come gli intellettuali del periodo, seguaci del dettato pirandelliano, sentano l’esigenza di approcciarsi ad ogni forma del reale, dal quotidiano, all’esistente e alla complessità di tutte le componenti etico-psicologiche, intrinseche nell’universo umano, spesso antagonistiche e conflittuali.
La formula teatro-verità-vita viene compresa anche da R. Leoncavallo, che, come abbiamo detto, aveva scritto e musicato l’opera “I Pagliacci”.
L’opera di Leoncavallo presenta analogia di contenuto e di ambientazione con la Cavalleria Rusticana di P.Mascagni.
I protagonisti dell’opera compongono una compagnia teatrale, giunta in un paesino meridionale, Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, per iscenare una commedia, che racconta di un “pagliaccio” Taddeo, che nella commedia viene tradito dalla moglie Colombina. La fictio si confonde con la vita realmente vissuta dai personaggi.
I personaggi principali sono Conio, la moglie Nedda (chiaro richiamo verghiano), Tonio, innamorato di Nedda, ma da quest’ultima respinto e Silvio, contadino del luogo con cui Nedda intreccia un legame amoroso e Beppe, che impersona Arlecchino.
Conio, avvertito da Tonio del tradimento, rincorre i due amanti, ma non riesce a vedere nel volto Silvio, che fugge. Nel frattempo arriva uno degli attori a sollecitare l’inizio della commedia perché il pubblico la reclama.
Da questo momento si comprende che è inscindibile il nodo che lega la vicenda narrata dalla commedia alla vita reale dei personaggi, che la rappresentano. Assume, in tal modo significativa valenza il prologo interpretato da Tonio, che è considerato il primo manifesto esplicito del verismo musicale e che ivi riportiamo:
Si può?.
(poi salutando)
Signore! Signori!… Scusatemi
se da sol me presento. Io sono il prologo:
poiché in iscena ancor le antiche maschere
mette l’autore, in parte ei vuol riprendere
le vecchie usanze, e a voi di nuovo inviami.
Ma non per dirvi come pria: «Le lagrime
che noi versiam son false! Degli spasimi
e de’ nostri martir non allarmatevi!»
No. L’autore ha cercato invece pingervi
uno squarcio di vita. Egli ha per massima
sol che l’artista è un uomo e che per gli uomini
scrivere ei deve. Ed al vero ispiravasi.
Un nido di memorie in fondo a l’anima
cantava un giorno, ed ei con vere lagrime
scrisse, e i singhiozzi il tempo gli battevano!
Dunque, vedrete amar sì come s’amano
gli esseri umani; vedrete de l’odio
i tristi frutti. Del dolor gli spasimi,
urli di rabbia, udrete, e risa ciniche!
E voi, piuttosto che le nostre povere
gabbane d’istrioni, le nostr’anime
considerate, poiché noi siam uomini
di carne e d’ossa, e che di quest’orfano
mondo al pari di voi spiriamo l’aere!
Il concetto vi dissi… Or ascoltate
com’egli è svolto.
(gridando verso la scena)
Andiam. Incominciate!
Il testo presenta molte affinità con altre tematiche e teorie estetiche, proposte dagli autori della letteratura realistica, da Verga, a Capuana,a Pirandello.
Il nucleo fondante del brano concerne la tematica del vero, che ogni autore dall’artista, al letterato, al musicista deve prefiggersi per dipingere “uno squarcio di vita”.
Comune al Verga e a Pirandello e ai teorici della critica estetica, è l’esigenza, evocata nel testo succitato, per l’autore di “essere un uomo che per gli uomini deve scrivere”. L’invito, inoltre, a considerare gli attori non come “povere gabbane d’istrioni”, ma a comprenderne nell’intimo l’anima, è una chiara concezione di un teatro, che sempre più deve tendere alla verità.Il teatro, per dirla sempre con Pirandello, doveva uscire dalla forma, in cui si era cristallizzato, per tornare al flusso primigenio ed incandescente dell’autentica vita.
La lingua musicale nelle opere di Mascagni e di Leoncavallo, pertanto, tende a ripetere nelle note, come nella scrittura letteraria o nei codici delle arti figurative, la voce possente della natura, nella quale l’uomo riconosce e rivela sua essenza.
Di stampo pirandelliano possiamo considerare anche la romanza cantata da Taddeo “Vesti la giubba”
Vesti la giubba e la faccia infarina.
La gente paga e rider vuole qua.
E se Arlecchin t’invola Colombina,
ridi, Pagliaccio… e ognun applaudirà!
Tramuta in lazzi lo spasmo ed il pianto;
in una smorfia il singhiozzo e ‘l dolor…
Ridi, Pagliaccio, sul tuo amore infranto!
Ridi del duol che t’avvelena il cor
E’ facile riscontrare in questo brano la problematica pirandelliana, concettualizzata nella raffigurazione dell’erma bifronte, che da una parte piange e dall’altra ride.
La compresenza, inoltre, di temi verghiani e problematiche pirandelliane, nel filone della musica verista, trova la sua matrice nella comune radice regionalistica dei due autori e nella lettura, che ne fanno, sia pure con differenziazione di stilemi artistici, delle variegate contraddizioni che l’humus siciliano comprende e nel quale si erano appalesate contraddizioni, riflesse altresì, nella realtà non solo socio-economico della regione, ma anche nella condizione esistenziale degli uomini che la abitavano
Il che, come abbiamo avuto modo di osservare, assume agli occhi dei nostri autori, un carattere, che si allontana da un principio particolaristico o regionalistico per trasferirsi, poi, nel paradigma di un’arte, che si rivolge a tutta quanta l’umanità.
Letteratura, in particolare, e mondo musicale percorrono i medesimi itinerari e gli stessi intenti. Esemplificativo del principio esposto può considerarsi lo stessa azione scenica de “I Pagliacci”.
Canio, nel ruolo di pagliaccio impersona un marito tradito dalla sposa Colombina.
La realtà e la finzione finiscono col confondersi e Canio,nascondendosi dietro Il personaggio, riprende il discorso interrotto dalla necessità di dare inizio alla commedia e, sempre recitando, rinfaccia a Nedda la sua ingratitudine e, trattandola duramente, afferma che il suo amore è ormai mutato in odio e gelosia. Di fronte al rifiuto di Nedda di dire il nome del suo amante Canio uccide lei e Silvio,accorso per soccorrerla. Tonio e Beppe, inorriditi non intervengono, ma gli spettatori comprendono troppo tardi che ciò che stanno vedendo non è più finzione, cercano invano di fermare Canio, che, a delitto compiuto, viene arrestato e Tonio esclama beffardo con un acuto declamatorio “ La commedia è finita”
Come nella grande tragedia greca, alla fine, la rappresentazione trova il suo culmine nell’aprodèscaton (imprevisto),mentre alla finzione subentra tumultuosamente la realtà. Concludendo possiamo affermare che le due opere La Cavalleria Rusticana e I Pagliacci sono da ritenere un testo unico, che rappresenta, oltre gli aspetti peculiari della corrente verista musicale,che si intreccia con la corrente letteraria, l’impegno degli intellettuali del tempo a colloquio con il popolo.
Questo ci spiega,inoltre,il fatto che le due opere vengono rappresentate insieme sin dal 1926, anno, nel quale per la prima volta Mascagni al Teatro della Scala,le diresse congiuntamente.
3
Il realismo nell’arte pittorica: G.Courbet- G .Pelliza da Volpeda
Il panorama storico-culturale ,di cui abbiamo parlato nella prima parte del nostro discorso, influenza decisamente anche l’arte pittorica.
I pittori rifiutano l’idealismo, si legano al positivismo,alle teorie marxiste.
Conseguentemente mutano la grammatica e l’iconolgia nell’ideazione e nella composizione delle opere d’arte.
I codici della raffigurazione artistica sono realistici e si instaura un rapporto più diretto tra l’autore e il suo pubblico.
L’autore,infatti,tutto calato nel reale, intende colloquiare col fruitore dell’opera d’arte non come artista,ma prevalentemente come uomo.
E’ da ricordar tra gli autori più rappresentativi della corrente realista Gustave Courbet. (1818-1877). Invero abbiamo ragione di ritenere che il Courbet esprime compiutamente, anticipandolo, ancora prima di tanti altri autori coevi, il complesso moto di idee e di ispirazioni artistiche, culminato, poi, nel periodo intercorrente tra la seconda metà dell’800 e i primi decenni del ‘900 in tutta Europa.
Il pittore, nel momento, in cui la società in Francia nel 1848 fu scossa violentemente da tumulti, che determinarono l’abdicazione di Luigi Filippo, si schierò con le insurrezioni popolari.
Nell’opposizione al capitalismo e alla borghesia faceva sue le istanze di Marx, che proprio nel 1848 pubblicava il Manifesto dei Comunisti e si avvicinava alla filosofia del positivismo sociale
Accoglieva inoltre i moniti,che la letteratura francese, da Balzac,a Flaubert, a Zola propagava nell’orizzonte culturale del tempo, maturando novità di pensiero e di forma artistica. Significativa è stata anche per il pittore l’amicizia con Baudelaire e Proudhon. Per meglio comprendere, però, il mondo di Courbet, l’originalità della sua ispirazione e, di conseguenza. il suo modo di leggere la realtà e di comunicarla al pubblico, ci limitiamo ad esaminare una sola opera dell’autore “Lo spaccapietre” (1849)
[Per visionare l’opera, dopo aver selezionato il link sottostante,cliccate e seguite le indicazioni seguite le indicazioni e aprie alla voce “vai alla pag.htp www…]
http://www.francescomorante.it/pag_3/303aa.htm
Fra i molti dipinti di Courbet e, che, in questa sede sembra superfluo enumerare, la scelta è motivata dal fatto che proprio “Lo spaccapietre” appare un documento-pittura conducente al nostro discorso sia per la rappresentazione dei personaggi,assimilabili a quelli di Verga, di Pirandello, Zola, sia per la valenza estetica espressa,che ha come fulcro la natura che parla da sola e che si relaziona con l’essenza stessa dell’uomo.
Opportunamente osserva l’Argan che il pittore nello “Spaccapietre” “più che rappresentare la realtà, si immedesima in essa………………..Un realismo ideologicamente orientato non sarebbe più un realismo, perché non rifletterebbe la realtà com’è ma come si vorrebbe o non si vorrebbe che fosse. Il realismo di Courbet, tuttavia,risponde alla necessità di prendere coscienza della realtà nelle sue lacerazioni e contraddizioni,” di immedesimarsi con essa, di viverla; di formarsi cioè quella nozione della situazione oggettiva, senza la quale l’ideologia non è spinta rivoluzionaria,ma pura utopia”.
Le parole dell’Argan ci inducono a riflettere sull’essenza della creazione artistica dell’autore : i segni pittorici diventano gli stessi segni della natura, nella quale Courbet si immedesima a tal punto da suggellare un modo tanto nuovo quanto suggestivo di leggere tutto quanto il reale per poi comunicarlo in forma autentica al suo pubblico.
Inoltre un’arte, come quella di Coubert, aliena da schemi ideologici e non utopica,del tutto immediata e spontanea,tanto da sembrare originarsi dalla natura stessa,ha l’efficacia di esprimere tutta quanta la realtà, le sue lacerazioni e le sue contraddizioni.
Che forse non è questo il principio fondamentale, che farà muovere la penna dei nostri scrittori e pensatori dell’ultimo scorcio dell’800 e nei primi decenni del ‘900,indicando alla nostra generazione quale debba essere la ragione vera dell’arte nella sua corrispondenza con la natura e con l’uomo in particolare?
La natura stessa diventa parola e la parola non può che avere un unico destinatario l’uomo, anzi per dirla con Kant, l’uomo in quanto uomo .Per Courbet l’arte trova il suo inveramento creativo-artistico in ciò che vede (lettura diretta del reale), in ciò che sente (sentimento puro ed immediato estraneo ad ogni forma di utopico ed astratto idealismo), in ciò che vuole (volontà ed impegno dell’artista-intellettuale nella costruzione di un’opera d’arte autentica e di comunicarla ad un pubblico, che non è più soltanto quello borghese, ma che comprende tutto quanto il popolo.
Uno dei suoi detti più significativi è,infatti; “ Fai quello che vedi, che senti, che vuoi” può essere considerato il proclama dell’artista-intellettuale rivolto alle nuove generazioni.
Courbet stesso delineò in principi programmatici del realismo (G. Courbet-Il realismo, Lettere e scritti a cura di M. De Micheli-ed.Treccani,Milano 1954 pp.25-26)
“L’attributo di realista mi è stato imposto come agli uomini del 1830 s’impose quello di romantici. In ogni tempo le etichette non hanno mai dato una giusta idea delle cose; se fosse stato diversamente le opere sarebbero superflue.Senza soffermarci sulla maggiore o minore proprietà di una qualifica,che nessuno, giova sperarlo,è tenuto a comprendere sino a fondo,mi limiterò a qualche parola di chiarimento per tagliar corto ai malintesi. Ho studiato, al di fuori di qualsiasi sistema e senza prevenzioni,l’arte degli antichi e quella dei moderni.Non ho voluto imitare gli uni, né copiare gli altri;né ho avuto l’intenzione di raggiungere l’inutile meta dell’arte per l’arte. No .Ho voluto semplicemente attingere dalla perfetta conoscenza della tradizione il sentimento ragionato e indipendente della propria individualità. Sapere per potere,questa fu sempre la mia idea. Essere capace di rappresentare i costumi, le idee,l’aspetto della mia epoca, secondo il mio modo di vedere;essere non solo un pittore ma un uomo; in una parola fare dell’arte viva, questo è il mio scopo”.
Al fine di chiarire ancora qualche aspetto di una pittura del periodo dialogante con le tematiche esposte dalla corrente cosiddetta del verismo, ma che noi preferiamo chiamare del realismo, accenniamo all’opera di Giuseppe Pel- lizza da Volpeda (1868-1908),sincero e convinto pittore di fine secolo ‘800, interprete profondo delle istanze sociali,che si agitavano nel tempo.
II pittore volge il suo sguardo all’umanità colla forza, oltre che del suo pensiero, con l’intensità di un palpitante sentimento di viva condivisione alla lotta, intrapresa dal popolo, per il proprio riscatto socio-economico ed esistenziale.
Sue sono le parole, scritte nel 1980: “Il mio scopo è quello di esprimere le verità che arrivano al mio intelletto……….Amo più essere giusto nel pensiero che nella forma”.
La sua opera più famosa è il Quarto Stato.
In quest’opera l’autore rivela fede nel progresso e nell’emancipazione del popolo, allineandosi, in tal modo ai processi evolutivi e ai fermenti di pensiero, che ebbero inizio nei primi decenni dell’’800, ma che si svilupparono concretamente anche in movimenti a carattere nazionale e sopranazionale verso la fine dell’800, argomento, di cui abbiamo parlato all’inizio del nostro discorso.
Secondo l’Argan, il Quarto Stato è Il primo documento di fermo impegno dell’arte nella lotta politica del proletariato.
[ Per visionare l’immagine seguire le procedure innanzi indicate a proposito di Courbet]
http://www.arte.it/opera/quarto-stato-1606
Quarto Stato (1901), olio su tela, cm 293×545, Milano, Museo del Novecento .
Il Quarto Stato fu dipinto da Pellizza tra il 1898 e il 1901 e venne acquistato per pubblica sottoscrizione dal Comune di Milano nel 1920; da allora fa parte delle Civiche Raccolte d’Arte (oggi Galleria d’Arte Moderna presso palazzo Belgiojoso Bonaparte in via Palestro). Pellizza decise il titolo con cui il quadro è universalmente noto poco prima di inviarlo alla Prima Quadriennale di Torino del 1902, in sostituzione del precedente , con una più consapevole scelta di classe, maturata a margine di letture socialiste e anche di una riflessione sulla Storia della rivoluzione francese di J. Jaurès, che in quegli anni usciva in edizione italiana economica e a dispense. Il soggetto è ispirato ad uno sciopero di lavoratori, un tema che aveva interessato i pittori del realismo europeo alla fine dell’Ottocento (da Lo sciopero dei minatori di Alfred-Philippe Roll del 1884 a Sciopero di Plinio Nomellini del 1889, a Una sera di sciopero di Eugene Laermans del 1893).Rispetto ai contemporanei il quadro di Pellizza rifiuta caratterizzazioni di eccitata protesta o di passiva rassegnazione, ma legando il tema iconografico dello sciopero con quello della sfilata che caratterizzava le celebrazioni della festa dei lavoratori, presenta una schiera di braccianti che avanza frontalmente, guidata in primo piano da tre persone in grandezza naturale: un uomo al centro affiancato, in posizione leggermente arretrata, da un secondo lavoratore più anziano e da una donna con un bimbo in braccio. La scena si svolge su una piazza illuminata dal sole chiusa sul fondo da folte macchie di vegetazione, che schermano anche le architetture esistenti, e da una porzione di cielo bluastro con striature rossastre iscritta in una cornice centinata. L’organizzazione dei personaggi fu lungamente studiata da Pellizza attraverso disegni preparatori a carboncino e gesso di grande suggestione compositiva e chiaroscurale: disegni singoli per i tre protagonisti, a gruppi per i personaggi in secondo piano, e di dettaglio per teste o mani delle ultime figure sul fondo. Come i tre personaggi principali non si collocano su un’unica linea ma hanno un’impostazione leggermente a cuneo, così anche i personaggi in secondo piano sono solo apparentemente disposti a schiera, perché in realtà, come è ben evidenziato anche dalle loro ombre, si distribuiscono secondo una linea ondulata ribadita da un analogo comporsi del movimento delle mani nonché dal ritmo e dalla direzione delle loro teste. Questa soluzione contribuisce a evitare che il tutto appaia statico e greve, e a suggerire invece un movimento ritmico e continuo, che ben rappresenta ed evidenzia l’idea dell’avanzata. Anche le diverse condizioni di luce concorrono ad accentuare questa impressione di moto, perché mentre lo sfondo del cielo rappresenta un tramonto, le figure sono viste in una luce quasi meridiana: si accentua in tal modo l’idea dì un trascorrere del tempo e quindi di un collocarsi dell’episodio in uno spazio e in un tempo apparentemente unitari e contingenti, ma, in realtà, espressione di una dimensione più articolata e capace di alludere a un lampo e a una natura che diventano il simbolo di una storia e di valori più universali. In essi, infatti, si materializza l’avanzare inarrestabile di uomini e donne le cui connotazioni descrittive di età e di classe vengono rielaborate e riassorbite in forme nutrite di una profonda cultura pittorica che attinge ai modelli rinascimentali (Raffaello, Michelangelo, Leonardo, Botticelli) lungamente studiati nei musei di Firenze, nelle Stanze e nei Palazzi Vaticani, e sulle fotografie Alinari, che di tali capolavori documentavano efficacemente forme, ritmi e articolazioni compositive. La volontà dell’autore di misurarsi al tempo stesso con la contemporaneità e con la storia si traduce non nella semplice riproposizione di un episodio contingente di uno sciopero o di una manifestazione di protesta, da cui pure aveva tratto fin dal 1891 la prima idea del quadro – in una ricerca che aveva prodotto il più oggettivamente naturalistico Ambasciatori della fame del 1892 e l’interpretazione meno oggettiva e fortemente simbolista di Fiumana del 1895-96 -, ma nella ideazione di un quadro capace di esaltare l’oggettività delle forme e di simbolizzare tutto il cammino che la classe lavoratrice aveva fatto e si preparava a compiere, un cammino di affrancamento dall’abbrutimento della fatica verso una più umana consapevolezza del proprio valore e della propria forza, un percorso frutto di azione ma anche di pensiero.
Un simile elogio della contemporaneità non poteva essere realizzato se non con una tecnica capace di essere assolutamente moderna, e cioè scientificamente controllata nei passaggi costruttivi della figura ma anche nello studio degli accordi e dei contrasti delle luci a partire dalle basi offerte dalla fisica e dalla chimica ottocentesche. Il Quarto Stato è un’opera complessa, frutto di una tecnica cromatica matura ed efficace. Sulla grande tela, preparata a colla e gesso, Pellizza tracciò le linee di riferimento necessarie per costruire i numerosi personaggi su vari piani e la scena d’ambiente, utilizzando veline ricavate a penna sulla base di diversi cartoni a carboncino; intervenne poi col colore che usò puro, nella ricca gamma di toni messa a disposizione a fine Ottocento dalla casa parigina Lefranc, e che applicò a punti e lineette secondo le leggi del divisionismo, per rendere non solo effetti convincenti di luce ma anche di ariosità e di massa sia nel paesaggio sia nelle figure. Nel piano d’appoggio dominano tonalità ocra e rosate, che trovano il loro punto di massima accensione nel gilet rosso del personaggio in primo piano; nelle figure gli abiti sono realizzati con colori verdastri e giallo sulfurei, ottenuti con una ripetuta sovrapposizione dei vari pigmenti colorati, studiati nelle loro interferenze e nei loro timbri sulla base di cerchi cromatici del tipo elaborato da N.O. Rood (Modern Chromatics uscito a Londra nel 1879), capaci di determinare particolari intensità di toni sfruttando le leggi del contrasto e della complementarità. Anche la dimensione e la direzione delle pennellate contribuiscono a costruire le forme in modo tale da garantire a esse volume pur senza accentuarne la pesantezza o la robustezza. Analoga sapienza denotano le macchie di vegetazione che mediano con il loro controluce e la ricchezza de! fogliame tra la piena luminosità del primo piano e il corrusco tramonto di fondo. Proprio queste caratteristiche di serena oggettività, ma anche di forza e di sicura determinazione hanno contribuito a definire il valore simbolico dell’opera adottata come manifesto dai lavoratori e dalle loro associazioni fin dall’inizio della sua storia espositiva, all’origine di una lunga serie di usi e di riprese soprattutto nella seconda metà del Novecento.
[Testo di Aurora Scotti, tratto da Cento opere. Proposte di lettura, in Enciclopedia dell’arte, Milano (Garzanti) 2002]
CAPITOLO TERZO
Verso la “lettura” del paesaggio verghiano
1) Il paesaggio nel Verga
2) Gli archetipi letterari nel paesaggio verghiano: Teocrito e Virgilio-analogie e contrapposizioni-
1
Il paesaggio nel Verga
Il nostro discorso, sino adesso sviluppato, ci convince che l’opera d’arte,nel periodo,oggetto del nostro studio, si realizza “iuxta naturae principia”.Questo presupposto,invero, presente nell’età classica, viene riproposto dal Verga, che lo adatta, pero,al contingente storico e al reale umano ed esistenziale, in cui lo scrittore vive ed opera. Nel Verga,giusta la congettura critica del Bachtin (M.Bachtin-Le forme del tempo e del romanzo-Einaudi-Torino- 1979)tempo storico o lineare tende a sparire,riassorbito nel ciclo eterno della natura”. Il che ci induce a considerare il paesaggio verghiano nella sua storicità temporale e al contempo nella sua idealizzazione simbolica.
Lo stesso Bachtin, nell’intento di focalizzare il concetto di cronotopo nell’opera verghiana, adduce ad esemplificazione la pagina iniziale de “I Malavoglia”,nella quale vengono presentati i personaggi ambientati in un paesaggio, che ha connotazioni del tutto realistico-naturalistiche.
“ Un tempo i Malavoglia erano stati in paese numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza”. Il paesaggio, che fa da sfondo alla vicenda, che lo scrittore si accinge a narrare, è quello delle burrasche ed assume un carattere metaforico preconizzante le avversità, verso cui i personaggi sarebbero andati incontro.
“Le burrasche che avevano disperso di qua e là gli altri Malavoglia erano passate e senza far gran danno alla casa del nespolo e sulla barca ammarata sul lavatoio”
Gli elementi descrittivi sono realistici e raffigurano una perfetta coincidenza tra storia e paesaggio,intriso di sofferenza. Il paesaggio,tuttavia, nel Verga si trasferisce sul piano dell’idillio. Acutamente, al riguardo,il Bachtin definisce, puntualizzando nel testo verghiano l’unità organica tra spazio e tempo, in cui si muovono i personaggi e si snodano le loro vicende, cronotopo il risultato della resa artistica dell’autore nella descrittività paesaggistica.”L’idillio”, dice lo studioso, “è l’unione della vita umana e della natura, l’unità del loro ritmo, il comune linguaggio per i fenomeni della natura e per gli eventi della vita umana”.
L’intelligente affermazione critica del Bachtin ci motiva alla lettura,sia pure brevemente sommaria di alcuni loci verghiani. Il motivo del paesaggio in Verga,come possiamo dedurre dal brano, che ci apprestiamo a riportare, talora assume l’aspetto valoriale-simbolico dell’accumulazione della roba.
Si legge nella novella “La roba”
“Un uliveto folto,come un bosco,dove l’erba non spuntava mai e la raccolta durava fino a marzo- Erano gli ulivi di Mazzarò- E verso sera,allorché il sole tramontava rosso e la campagna si velava di tristezza, si incontravano le lunghe file degli aratri di Mazzarò che tornavano adagio al maggese, e i buoi che passavano al guado lentamente col muso all’acqua scuri; e si vedeva nei pascoli lontani della Carinzia nella pendice brulla,il fischio del pastore echeggiava nelle gole e il capannaccio che risuonava or sì or no, e il canto perduto nella valle.-Tutta roba di Mazzarò-“
Il paesaggio è coerente alla stessa vita di Mazzarò- Dice il Luperini: “Uomo e natura si scambiano le parti in una sorta di panismo lirico antropocentrico”
Analogamente quando mastro-don Gesualdo s’incammina per i campi, che costituiscono il cumulo della sua ricchezza, attraverso la quale tenta con fatica il suo riscatto sociale, lo sfondo naturalistico, nel riflettere l’immane fatica dell’arrampicatore sociale, si colora di fosche tinte, espressione di disperazione e solitudine.
Leggiamo
…….Brontolava ancora allentandosi nell’ambio della mula sotto il sole cocente: un sole che spaccava le pietre adesso, e faceva scoppiettare le stoppie quasi si accendessero. Nel burrone, fra i due monti, sembrava d’entrare in una fornace, e il paese in cima al colle, arrampicato sui precipizi, disseminato in rupi enormi, minato da caverne che lo lasciavano come sospeso in aria, nerastro, rugginoso, sembrava abbandonato, senza un’ombra, con tutte le finestre spalancate nell’afa, simile a tanti buchi neri; le croci dei campanili vacillanti nel cielo caliginoso…………………
Osserva al riguardo G. Mariani (Letteratura Italiana- I Maggiori- vol.II-Marzorati ed. –Milano-1956-pag.1239) “La fede nella roba dà luogo a un dolcissimo canto che celebra la poesia del paesaggio, ma anche il paesaggio esiste in quanto roba, in una disperata sintesi che è certo una delle più alte conquiste verghiane. Da ora in poi il paesaggio non esisterà come tema a sé, ma come spietata ed amara conquista d’ogni giorno che l’uomo “nato per la roba”compirà senza soste, con implacabile ardore, bruciando se stesso e i suoi affetti in un’implacabile ardore, che ha come ultima meta la disperazione e la solitudine”.
Concludendo la sua giornata mastro-don Gesualdo si abbandona all’idillio contemplando nella Carinzia la luna accanto alla sua fedele e devota Diodata.
“Egli uscì furori a prendere il fresco.Si mise a sedere su un covone, accanto all’uscio,colle spalle al muro,le mani penzoloni tra le gambe. La luna doveva essere già alta, dietro il monte, verso Francofone. Tutta la pianura di Passanitello, allo sbocco della valle era illuminata da un chiarore di alba. A poco a poco, al dilagar di quel chiarore,anche nella costa cominciarono a spuntare i covoni raccolti in mucchi,come tanti sassi posti in fila. Degli altri punti neri si muovevano per la china , e a seconda del vento giungeva il suono grave e lontano dei campanacci che portava il bestiame grosso verso il torrente. Di tratto in tratto soffiava pure qualche folata di venticello più fresco dalla parte di ponente, e per tutta la lunghezza della valle udivasi lo stormire delle messi ancora in piedi .Nell’aia la bica alta e ancora scura sembrava coronata d’argento, e nell’ombra si accennavano confusamente gli altri covoni in mucchi; ruminava altro bestiame; un’altra striscia d’argento lunga si posava in cima al tetto del magazzino, che diventava immenso nel buio…………………………Egli non aveva sonno. Si sentiva allargare il cuore. Gli venivano tanti ricordi piacevoli.Ne aveva portato delle pietre sulle spalle, prima di fabbricare quel magazzino!……”
E’ stato giustamente osservato che il brano che abbiamo riportato rappresenta l’unico momento di idillio, vissuto dal personaggio.
La natura non si presenta, come nel racconto della prima giornata di travaglio arsa, arida, brulla, ma viene illuminata dal chiarore lunare e l’atmosfera è umbratile. La suggestione di quel paesaggio evoca in Mastro-don Gesualdo i ricordi della sua fanciullezza, il duro lavoro affrontato prima di poter possedere quel magazzino, che sembrava immenso nel buio.
Commenta A.Momigliano (A.Momigliano in Da Dante,Manzoni,Verga-D’Anna ed. pp.259-60)
“Dovunque penetra il respiro tranquillo di don Gesualdo, che, dopo la corsa sotto il cielo in fiamme, allenta il corpo e la mente, lascia che la calma dell’ora tarda smorzi la sua fatica, si ristora nella buia frescura della notte. La solitudine ridesta i ricordi lontani di don Gesualdo travagliato nella conquista dell’agiatezza: è un momento di poesia nella sua vita infaticabile, la poesia della sua esistenza di lottatore, il respiro di sollievo di chi è salito e ripercorre con l’occhio l’ascesa. Nemici, pericoli, liti, ostacoli, tutto ritorna in quest’ora di ricordi, ma raddolcito dalla lontananza, immerso nella serenità della notte estiva,ammorbidito e sfumato di tenerezza dalla vicinanza muta di quell’umile donna amata(Diodata)”
Come possiamo arguire dalle parole del Momigliano si tratta soltanto di una parentesi idilliaco-lirica all’interno del romanzo. Poi l’idillio svanisce e nel ricordo della sua ascesa sociale mastro-don Gesualdo ripropone in modo incalzante il tema della roba. Ne “I Malavoglia”,invece, il paesaggio assume un carattere più costantemente consolatorio ed unitario.
Nel paesaggio, sembra realizzarsi, sia pure con tonalità melanconica,il rapporto armonico tra l’uomo e la natura. La scrittura narrativa, allora, diventa cifra poetica nel momento stesso in cui il Verga trasferisce voci e colori della natura nella vita semplice degli umili personaggi.
L’idillio, inoltre, sia ne “I Malavoglia” sia in molte novelle, scritte dal Verga, emblematizza il ritorno al sogno del passato, a quella assolutezza edenica, dispersa e travolta dalla corrente del progresso. Ad esemplificazione leggiamo da “I Malavoglia” L’addio di ‘Ntoni
“E se ne andò colla sua sporta sotto il braccio, poi quando fu lontano, in mezzo alla piazza scura e deserta, che tutti gli usci erano chiusi, si fermò ad ascoltare se chiudessero la porta del nespolo mentre il cane gli abbaiava dietro e gli diceva che con il suo abbaiare era solo in mezzo al paese Soltanto il mare gli brontolava la solita storia lì sotto, in mezzo ai faraglioni, perché il mare non ha paese nemmeo lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole, anzi ad Aci Trezza ha un suo modo di brontolare, e si riconosce subito al gorgogliare che fa tra quegli scogli nei quali si rompe, e par la voce di un amico. Allora ‘Ntoni si fermò in mezzo alla strada a guardare il paese tutto nero, come non gli bastasse il cuore di staccarsene, adesso che sapeva ogni cosa, e sedette sul muricciolo della vigna di massaro Filippo. Così stette gran pezzo pensando a tante cose, guardando il paese nero e ascoltando il mare che gli brontolava sotto. E ci stette fin quando cominciarono ad udirsi certi rumori ch’ei conosceva,e delle voci che si chiamavano dietro gli usci, e sbatter d’imposte, e dei passi per le strade buie.Sulla riva,in fondo alla piazza,cominciavano a formicolare dei lumi. Egli levò il capo a guardar i Tre Re che luccicavano e la Puddara che annunziava l’alba, come l’aveva vista tante volte. Allora tornò a chinare il capo sul petto, e a pensare a tutta la sua storia……………………..Tornò a guardare il mare, che s’era fatto amaranto, tutto seminato di barche che avevano cominciato la loro giornata anche loro,riprese la sua sporta e disse:-Ora è tempo di andarmene,perché fra poco comincerà a passar gente.”
Assai mosso è il sentimento che anima il lettore di questo brano mentre lo induce a riflettere. ‘Ntoni decide di andarsene,di rompere con la sua storia presente; è un atto di ribellione, anche se il personaggio sa di incamminarsi verso l’ignoto. Soltanto la natura riesce a parlare al suo animo con voce genuina ed autentica. Il mare, avvertito come ciclo perenne di essere e divenire “di qua e di là dove nasce e muore il sole…….brontolava”. E’ un mare aperto “senza paese” che sa parlare ed ascoltare. E’ la voce di un amico.
All’immensità del mare illuminato dalle prime luci dell’alba si contrappone il paese tutto nero. L’oscurità del paese è una connotazione dell’impossibilità e della tragicità del vivere del personaggio. Quando l’alba comincia a spuntare, però,‘Ntoni riprende il suo cammino allontanandosi definitivamente dalla casa del nespolo e dal suo paese “tornò a chinare il capo e a pensare a tutta la sua storia……………..tornò a guardare il mare, che si era fatto amaranto,tutto seminato di barche che avevano cominciato la loro giornata, riprese la sua sporta e disse:- Ora è tempo di andarmene,perché tra poco comincerà a passare gente…”.
Il contrasto tra l’incanto incontaminato della natura e il buio del contingente storico reale ingenera il paesaggio del diario dell’anima di ‘Ntoni.
Soltanto la natura ha una parola di conforto per il personaggio nel momento,in cui si trova da solo a colloquio con essa.
Quando,invece, il paesaggio comincia a movimentarsi di persone, che iniziano il quotidiano lavoro, a ‘Ntoni non rimane altro che guardare ancora una volta il mare e andarsene.
La solitudine di ‘Ntoni si compendia nella solitudine del paesaggio (in mezzo alla piazza scura e deserta; tutti gli usci erano chiusi in mezzo al mare). Il personaggio, giusta l’annotazione contenuta nel testo-L.Poma-C.Ricciardi- Il secondo Ottocento-2002-Le Monnier a pag.189-“per la sua condizione di senza terra è assimilabile con un’altra metafora al mare che non ha paese “nemmeno lui”.
Ntoni vorrebbe ascoltare la voce del mare, che evoca la perennità di una vita ciclica ed eterna, ma allorquando si accorge che anche il mare anzi in Aci Trezza “ha un modo tutto suo di brontolare e si riconosce subito al gorgogliare che fa tra quegli scogli nei quali si rompe e par la voce di un amico”, il mare stesso diventa simbolo dell’affaccendarsi vorticoso dell’umana fatica per la sussistenza tra sussulti e impedimenti (il gorgogliare che fa tra quegli scogli nei quali si rompe).
A questo punto avviene la separazione tra personaggio e mare. ‘Ntoni deve allontanarsi, deve iniziare il suo cammino di ulisse senza ritorno e senza il conforto della voce amica del mare e non più rischiarato nell’anima dalle prime luci dell’alba.
Il contrasto dialettico, tra il mondo incontaminato della natura e la coscienza tragicamente sofferta di sua una frattura insanabile e conflittuale con il reale è al centro della novella Jeli il pastore, compresa nella raccolta Vita dei Campi.
Dall’incipit della novella Jeli il pastore
“Jeli, il guardiano di cavalli aveva tredici anni quando conobbe don Alfonso, il signorino, ma era così piccolo che non arrivava alla pancia della Bianca, la vecchia giumenta che portava il campanaccio alla mandria.Lo si vedeva sempre di qua e di là, pei monti e nella pianura, dove pascolavano le sue bestie, ritto ed immobile su qualche greppo, o accoccolato su di un gran sasso. Il suo amico don Alfonso mentre era in villeggiatura andava a trovarlo tutti i giorni che Dio mandava a Tebidi e dividevano fra loro i buoni bocconi del padroncino, e il pane d’orzo del pastorello, o le frutta rubate al vicino. Dapprincipio, Jeli dava dell’eccellenza al signorino, come si usa in Sicilia, ma dopo che si furono accapigliati per bene la loro amicizia fu stabilita saldamente. Jeli insegnava al suo amico come si fa ad arrampicarsi sino ai nidi delle gazze, sulle cime dei noci più alti del campanile di Licodia, a cogliere un passero a volo con una sassata, o montare correndo sul dorso nudo delle giumente ancora indomite, acciuffando per la criniera la prima che passava a tiro, senza lasciarsi sbigottire dai nitriti di collera dei puledri indomiti,e dei loro salti disperati. Ah! Le belle scappate pei campi mietuti, colle criniere al vento! I bei giorni di aprile,quando il vento accavallava ad onde l’erba verde, e le cavalle nitrivano nei pascoli! I bei meriggi d’estate, in cui la campagna bianchiccia, taceva sotto il cielo fosco e i grilli scoppiettavano fra le zolle, come se le stoppie si incendiassero! Il bel cielo d’inverno attraverso i rami nudi di mandorlo che rabbrividivano al rovajo, e il viottolo che suonava gelato sotto lo zoccolo dei cavalli, e le allodole che trillavano in alto, al caldo, nell’azzurro! Le belle sere di estate, che salivano adagio adagio come la nebbia, il buon odore del fieno in cui si affondavano i gomiti, e il ronzio melanconico degli insetti della sera, e quelle due note dello zufolo di Jeli, sempre le stesse-iuh! Iuh-iuh!-che facevano pensare alle cose lontane, alla festa di San Giovanni, alla notte di Natale, all’alba della scampagnata, a tutti quei grandi avvenimenti trascorsi, che sembrano mesti,così lontani, e facevano guardare in alto, cogli occhi umidi, quasi tutte le stelle che, andavano accendendosi in cielo, vi piovessero in cuore, e l’allagassero.”
Di particolare rilevanza è questa pagina sia per la panoramica della poetica verghiana sia per il messaggio in essa contenuto.
Per quanto attiene alla poetica l’autore realizza una scrittura tanto pregna di poesia quanto più la sua penna trasferisce nel foglio la voce della natura stessa.
Il messaggio, inoltre, che viene evocato è quello del dualismo natura-società. La natura è appagante per la vita autentica dell’uomo; dalla medesima derivano gioia, contemplazione estatica, moti di meraviglia e sincerità di rapporti.
Nell’età infantile, nel contatto colle forze vergini della natura,Jeli riesce a legarsi di sincera amicizia con il signorino Alfonso,infrangendo, in tal modo le barriere, che le convenzioni sociali imponevano. Ma allorquando il reale, con tutte le sue sovrastrutture di ordine socio-economico, subentra al vago-indistinto del sogno, che la natura aveva infuso al primitivo ed umile pastorello, la vicenda umana diventa realisticamente cruda e a questa si reagisce con istintiva violenza e con atti efferati.
E’ significativo che l’autore abbia descritto un paesaggio tanto soffuso di luci e colori soltanto nella prima parte della novella.
Segno questo che il paesaggio diventa metafora dell’animo di Jeli, attesa di una vita da vivere in armonia colla natura.
Il rapporto edenico Jeli-natura, però, s’infrange quando l’umile pastorello viene inviluppato dalla realtà e dalla società, in cui è costretto a vivere.
Notiamo Jeli, all’inizio della novella, muoversi fra i verdi prati in una cornice naturalistica propizia : “le belle scappate per i campi mietuti……….i bei meriggi d’estate in cui la campagna taceva…….i grilli scoppiettavano fra le zolle…….”.
La polifonia delle voci della natura e la sua policromia irradiano di gioia e spensieratezza Jeli. Anche nella cadenza di una prosa snella e al contempo concitata,ritmata da molti segni di interpunzione esclamativi, si delinea il trasalimento dell’anima genuina e spontanea di Jeli, che al pari degli antichi cantori, si accompagnava, talvolta, con lo zufolo, anche se suonava sempre le stesse note. L’incanto della natura riconduceva alla memoria eventi lontani e gioiosi, quali la festa di S. Giovanni, la notte di Natale con struggente nostalgia,mentre sembrava che le stelle che andavano accendendosi in cielo vi piovessero in cuore ,e l’allagassero.
Interessante è il giudizio critico, espresso da Asor Rosa (Asor Rosa- Il caso Verga-Palumbo-1973-pp.45 sgg.)
“In Jeli il pastore esprime a modo suo il sogno mitico di uno stato di natura che precede la costituzione di una società di uomini con le sue strutture e con le sue leggi……………………………………..La contrapposizione di base su cui nasce l’invenzione del racconto è perciò questa : da una parte Natura più Jeli,dall’altra la società tutta (tutto il mondo meno Jeli).In mezzo un abisso storico incolmato e (se si deve giudicare proprio dalla vicenda di Jeli) irrimediabilmente incolmabile……………………..Jeli è parte effettiva della natura, colla quale per l’appunto intrattiene un profondo, misterioso colloquio, che non ha soste”
Jeli, in effetti,come si dice nella novella era piovuto dal cielo e la terra lo aveva raccolto. Ma la terra, che lo aveva raccolto,si relazionava ad una società piena di storture e di contraddizioni.
Al pastore,che sapeva comunicare con la natura, era inaccessibile quel mondo immerso nell’ipocrisia,nella falsità,nella menzogna.
E’ un mondo questo ignaro al pastore e di cui disconosce costumi e leggi. Non potrà sopportare di essere tradito dal suo migliore amico il signorino Alfonso che gli concupisce la moglie. Jeli in un impeto primordiale d’ira ucciderà il rivale accoltellando alla gola (rituale di duello rusticano presente nella Cavalleria). Quando Jeli, poi, viene condotto davanti al giudice per essere processato, pronuncia questa frase: -Come!—-Non dovevo ucciderlo nemmeno——Se mi aveva preso la Mara!———–
Queste parole, che concludono la novella sono coerenti a fissare in modo preciso la fisionomia del personaggio,vigile scrutatore delle leggi della natura, renitente ed inconsapevolmente avverso a quelle della società, in cui viveva il suo quotidiano.
L’elementarità del paesaggio, come è stato detto, rappresenta la stessa elementarità del personaggio e ne esprime tutti gli attributi e le caratteristiche allo stesso connaturate.
Comprendiamo,in tal modo, come il paesaggio figura del personaggio stesso, si diversifica nei vari momenti compositivi dell’opera verghiana.
Vediamo,infatti, come nella raffigurazione di Rosso Malpelo, destinato a soccombere al suo atroce destino, è assente ogni componente idilliaca all’interno dello scenario, in cui si muove il caruso.
Domina nel luogo dell’incessante,faticante e disumano lavoro il colore nero della lava quasi a rappresentare la tragicità cupa dell’esistenza. E seppure c’è uno squarcio di elemento paesaggistico “il mare turchino e l’azzurro del cielo”, questo è visto in contrapposizione al buio della miniera, al tragico e doloroso vissuto del personaggio,che proprio da quel buio sarà inghiottito senza più riapparire.
Dice il Luperini ( R.Luperini-La scrittura e l’interpretazione-Storia e antologia della letteratura italiana-vol. V a pag.355)
“Il paesaggio evoca l’inferno:rena, roccia,picchi e burroni senza un segno di vita………..La miniera è il simbolo del labirinto, dello smarrimento nelle viscere della terra, ma anche della prigione, da cui non si può evadere che con la morte. Malpelo si identifica totalmente nel mondo sotterraneo fino alla scelta volontaria dell’annientamento in quel “buco nero” opposto al mondo degli altri, della luce, della vita comune, che lo ha escluso e rigettato per sempre tra le creature maledette.”
Diversamente si atteggia il paesaggio, che contorna il personaggio della Lupa. Il paesaggio è assolato e sembra ardere della stessa passione, che infuoca la Lupa “….la gnà Pina era la sola anima che si vedesse errare per la campagna, sui sassi infuocati delle viottole, fra le stoppie riarse dei campi immensi, che si perdevano nell’afa”
La campagna, che fa da sfondo all’errare della Lupa, simboleggia lo stato d’animo del personaggio, pervaso da indomabile passione. I sassi sono,infatti,infuocati, le stoppie riarse e tutta l’aria respira di afa.
E’ mirabile come il Verga con efficacia stilistico-descrittiva fa palpitare la natura con gli stessi sentimenti, che si agitano nel personaggio. La resa artistica compiuta dell’immedesimazione personaggio-natura conferisce al racconto un tono lirico-simbolico di alto significato poetico. Per comprendere ancora maggiormente la valenza, che il paesaggio assume nella poiesi artistica dell’opera verghiana, non possiamo non ricordarci di un’altra novella Malaria.
Sembra che il Verga, nello scrivere questa novella abbia voluto trasferire sul piano lirico-simbolico le parole-documento, comprese nell’Inchiesta di Franchetti e Sonnino (Frianchetti e Sonnino-La Sicilia-Firenze 1925- pp. 44-45)
“ Triste dote della vasta e ferace terra( terra benedetta da Dio, scrive il Verga) pianura di Catania è quella di essere il luogo dove maggiormente predomina la malaria e fanno stragi le febbri intermittenti e perniciose…..I Lavoratori lavorano tutto il giorno sotto la sferza di un sole cocente, e la notte dormono all’aperto, senza riparo di sorta, in mezzo ai miasmi micidiali: parecchi ne muoiono lì per lì, e molti riportano a casa i germi di una lunga malattia che li renderà inabili al lavoro o li trascinerà sicuramente alla tomba. E ciò per guadagnarsi per una o due settimane poche lire di salario!…”.
Dall’incipit della novella Malaria
“E vi par di toccarla con le mani!- come della terra grassa che fumi là, dappertutto, torno, torno alle montagne-che la chiudono da Agnone a Mongibello incappucciato di neve- stagnante nella pianura, a guisa dell’´afa stagnante di luglio. Vi nasce e vi muore il sole di brace, e la luna smorta, e la Puddara, che sembra navigare in un mare che svapori, e gli uccelli e le margherite bianche della primavera,e l’estate arsa; vi passano in lunghe file nere le anitre nel nuvolo dell’autunno,e il fiume che luccica quasi fosse di metallo, fra le rive larghe e abbandonate, bianche, slabbrate, sparse di ciottoli; e in fondo il lago di Lentini, come uno stagno, colle sponde piatte,senza una barca, senza un albero sulla riva, liscio ed immobile. Sul greto pascolano svogliatamente i buoi rari, infangati sino al petto, col pelo irsuto. Quando risuona il campanaccio della mandria, nel gran silenzio volan via le cuttrotole silenziose e il pastore istesso, giallo di febbre, e bianco di polvere anche lui, schiude un istante le palpebre gonfie, levando il capo all’ombra dei giunchi secchi. E’ la malaria che vi entra nelle ossa col pane che mangiate,e se aprite bocca per parlare,mentre camminate lungo le strade soffocanti di polvere e di sole, e vi sentite mancar le ginocchia, o vi accasciate al basto della mula che va all’ambio, colla stessa bassa”
In questa novella protagonista non è l’uomo, ma la malaria, che incombe sugli esseri umani e ne scandisce il destino.
La malaria accomuna gli elementi della natura, uomini e animali in un cammino di sconfitta e di morte.
All’interno della novella possiamo anche ravvisare le contraddizioni, già denunciate dall’Inchiesta di Franchetti e Sonnino, esistenti tra la fertilità della terra siciliana e le condizioni di fragilità e di miseria degli uomini, che la abitano. Il che fa vibrare nel Verga un profondo pathos, che si riverbera negli stilemi compositivo-descrittivi di un paesaggio desolato, che diventa, al contempo,parafrasi dello stato d’animo dei personaggi, che lo popolano. La natura è dominata dalle stesse leggi, che governano l’uomo: miseria e sofferenza.
Il sole,che appare nello scenario di questa novella, è di brace, quasi a definire l’anima disperata ed esacerbata degli umili lavoratori,mentre la luna smorta sembra voler accentuare con la disillusione una desolazione infinita. Dopo la comparsa della luna smorta si ha l’impressione che il panorama si slarghi ; si scorge la“ Puddara( la costellazione delle Pleiadi) che appare come se navigasse in un mare che evapori. Ma la visione della Puddara sfuma per dare luogo ad una rappresentazione naturalistica più sconfortante : “ gli uccelli e le margherite bianche della primavera e l’estate arsa e vi passano in lunghe file nere le anatre nel nuvolo di autunno”. Nella descrizione, pur se si tende in qualche modo ad esaltare la fecondità della terra le margherite bianche della primavera, poi si accenna all’estate arsa,aggettivazione questa che è riferibile all’aridità della vita personaggi. L’immagine successiva del nuvolo di autunno, verso cui si avviano le anatre in lunghe file nere denota l’opacità esistenziale della vita, condotta dai personaggi verghiani.
Anche il fiume sembra risentire del male di vivere: “il fiume che luccica tra le rive larghe e slabbrate”(slabbrate e, pertanto,deformate da colpi inferte dalla natura).
Lo stesso fiume si sente,pertanto,immerso nelle impervietà dell’esistente e la sua vita sembra seguire l’eguale triste ed inarrestabile destino degli uomini “senza una barca, senza un albero alla riva, liscio e immobile”. L’immobilità del fiume è paragonabile all’imperturbabilità ed ineluttabilità del fato ,così come il medesimo senza barca può raffigurare il naufragio dell’uomo chiuso nella sua solitudine.
Solitudine e desolazione sono nel Verga i temi fondamentali, trasposti dall’autore in questa pagina, non solo con l’intento artistico-poetico,ma soprattutto con l’impegno del letterato-intellettuale, che, nel documentare la realtà, riesce a creare una perfetta sincrasi tra il mondo della natura e l’universo umano.
Continuando a leggere la pagina verghiana, scopriamo che anche i buoi riproducono nella loro fatica il senso del travaglio esistenziale degli umani: “pascolavano svogliatamente,rari, infangati……”. “E verso la fine della descrizione non poteva mancare la presenza umana “ il pastore istesso giallo di febbre e bianco di polvere anche lui, schiude in istante le palpebre gonfie levando il capo ai giunchi secchi”. Alla condizione devastante dell’uomo, in preda alla febbre e sconsolato, fa da correlativo oggettivo la raffigurazione dei giunchi secchi. Invero gli effetti della malaria costituiscono la grammatica compositiva dell’inventività verghiana in questa pagina e per questo l’autore non la nomina nella primo capoverso del racconto. La parola malaria , è situata all’inizio del secondo capoverso: E’ la malaria che vi entra nelle ossa come il pane….ed è funzionale alla discorsività susseguente del racconto, dove si snoda la vicenda dei personaggi mediante codici linguistici più realistici e confacenti all’azione narrata. L’uso, inoltre, di registri linguistici differenziati,da quello simbolico-lirico della prima parte, a quello più dimesso nella seconda parte,sintetizza lo specimen dell’arte verghiana,tendente a descrivere tutta quanta la realtà dalle radici profonde dell’essere umano sino al suo interrelarsi con il mondo della natura e con il vissuto quotidiano. Nel Verga, inoltre, la diversità degli stilemi è correlata al diverso modo di essere, di manifestarsi e di comportarsi dell’individuo.
2
Gli archetipi letterari nel paesaggio verghiano: analogie e contrapposizioni
Le argomentazioni svolte c’inducono a riflettere che nell’arte verghiana il rapporto tempo-spazio e uomo-natura costituisce la peculiarità e l’essenza stessa della tematica del Verga.
Donde la specificità della sua estetica tendente, peraltro, ad una precisa rappresentazione del reale in tutte le sue componenti da quelle naturalistiche a quelle meramente umane.
In quest’ottica abbiamo cercato di interpretare anche il paesaggio verghiano, intessuto di un idillio, che riflette inoltre quell’amara condivisione di dolore, che accomuna natura ed uomini.
Desideriamo adesso soffermarci sull’aspetto dell’idillio, congeniale alla tematica verghiana e tentare di individuarne, per quanto possibile, gli archetipi nell’età classica.
Parlando d’idillio, che ha la sua forza poetica generatrice nella terra di Sicilia, in primis ci ricordiamo di Teocrito.
Teocrito (310-250 a.Chr.), come Verga, è fortemente legato alla Sicilia e, come Verga, predilige cantare la vita semplice dei suoi abitanti.
Ma se il topos è lo stesso, assai distante e diverso è il chronos.
Lo scrittore siciliano ritrae il paesaggio della Sicilia con fosche tinte drammatiche anche quando sembra indulgere ad un momento statico di contemplazione
L’idillio, infatti, viene vissuto dal Verga in contrapposizione al reale ed, anche quando questo si permea di un sentimento patetico-elegiaco, come nell’episodio dell’addio di ‘Ntoni, la natura risuona della nota dolente di un sogno nostalgico, non appagato, disperato, impossibile da realizzare.
In Teocrito,invece, il paesaggio della Sicilia appare rigoglioso, pieno di luci e avvolto da un’aura di serenità.
C’è da dire,inoltre,che Teocrito, pur tendendo ad un certo realismo di linguaggio e d’ambientazione, trasferisce la materia del suo canto in orizzonti meramente letterari.
Bisogna,però, sottolineare che, come in Verga,anche in Teocrito la natura è parafrasi sensibile dei sentimenti umani.
C’è da osservare che,mentre in Teocrito la natura,contemplata nel suo tripudio, è la stessa gioia della vita,in Verga presenta un volto assai più contraddittorio e conflittuale e partecipa delle vicissitudini del genere umano.
Nel paesaggio, invece,Teocrito si abbandona al sogno, immergendosi in una natura felice e benigna.
Ad esemplificazione i vv.135-142 dalle Talisie
Folti sul nostro capo ondeggiavano in alto
pioppi e olmi: e accanto la sacra acqua
stillante dall’antro delle Ninfe mormorava.
Sopra i rami ombrosi le cicale amanti del sole
erano affaccendate a ciarlare, e lontano
fra i rivi folti di spini gracidavano le rane,
cantavano allodole e cardellini, gemeva la tortora
e bionde api volavano intorno alle fonti.
Anche se il poeta tende a rappresentare una realtà oggettuale della natura, il tono poetico si impronta a forme di letterarietà tradite dalla cultura del tempo.
Persino quando vuol rappresentare il meriggio estivo o i colori festosi del paesaggio siciliano è presente la componente stilistico-letteraria.
Leggasi questo brano dell’Idillio XI IL Ciclope
Lascia che il mare turchino si franga a la riva ansimando
come più dolce la notte con me qui passerai nell’antro!
Qui sono allori, qui svettano i bei cipressi slanciati,
d’ellera brune volute, qui vite dei grappoli dolci:
spiccia qui gelida l’acqua che l’Etna selvoso m’invia,
da le sue candide nevi, ambrosia bevanda a la sete;
queste dolcezze chi mai, per i mari ed i flutti, darebbe!
( trad. E. Bignone)
Lo sfondo naturalistico in questo brano ha la sua ragione di essere in rapporto al mito: l’amore vano cantato da Polifemo per Galatea e per questo si libra in un’atmosfera del tutto ideale.
Dice il Pascucci (G. Pascucci- Storia della letteratura italiana-Sansoni-1963-a pag.357)
“Trionfa nel più puro paesaggio, quello più liricamente sentito, l’azzurro del cielo e del mare di Sicilia, l’ardore e il rigoglio delle sue estati, la fecondità delle sue greggi, l’ardente passione e la mimica vivacità dei suoi pastori; più spesso è paesaggio composto, fatto di elementi estranei alla natura e ricavati dall’esperienza letteraria”
Eppure in questa cornice di carattere bucolico Teocrito, come farà più tardi Verga, anche con maggiore intensità, pone l’attenzione alla precisa descrizione di dati realistici e della vita quotidiana.
Invocando Galatea Polifemo parla di se stesso, del suo aspetto e della sua vita di tutti i giorni
Forse villoso soverchio ti sembro, ma qui nella grotta
legna ho di querce e, di sotto la cenere, brace mai spenta
e pure l’anima saprei sopportar che m’ ardessi,
e questa sola pupilla che m’è la più cara dolcezza!
( trad. E. Bignone)
Anche in questo caso l’aspetto realistico non si esaurisce in sé, ma è strumentale all’elegia di amore, secondo la tradizione bucolica.
Nel canto di Polifemo ci sembra,però, di invenire un elemento nuovo, che ci ricorda, sia pure con profonde e radicali differenze, un altro personaggio del Verga. Ci riferiamo a Jeli il pastore.
Nel presentare il personaggio di Polifemo, invero, Teocrito, ne opera una profonda trasformazione rispetto alla tradizione omerica.
Polifemo viene umanizzato, perde la sua ferinità e per questo riesce a modulare con la cetra un canto, che si accorda col paesaggio bucolico, che lo circonda e che ha il palpito della vita vissuta.
Soffre come tutti gli altri pastori innamorati senza speranza e tuttavia in un’intima comunione colla natura, come è stato osservato da S.Nicosia, giunge alla catarsi.
Anche Jeli, nella contemplazione della natura, nell’intuirne il fascino misterioso, sublima il suo animo e, soltanto compenetrandosi in essa, può trovare quella serenità, che la realtà gli negherà.
Nell’episodio teocriteo il paesaggio s’intona compiutamente al modulare del canto dell’anima del personaggio,laddove in Verga, invece, ed,in particolare, nel racconto di Jeli, assume un carattere antinomico e conflittuale con le vicende umane.
Per questo in Jeli è impossibile pervenire alla catarsi, anzi l’opposizione natura-realtà lo farà precipitare in un abisso incolmabile.
Anche quando Jeli tenta di suonare lo zufolo non riesce che a modulare poche note smorzate e sempre le stesse.
Segno questo che i suoi momenti idilliaci erano soltanto sporadici e comunque non tali da potere tramare un discorso compiuto.
La sua emozione, anche se sincera, non diventa consapevole parola dell’anima, né intende, né sa accogliere le suggestioni di moduli poetici, che, invece, sono presenti nell’opera teocritea.
E’ chiaro che i due autori Teocrito e Verga, pur ambientando i propri personaggi nello stesso humus, hanno proposizioni artistiche diverse.
La Sicilia di Teocrito è tutta immersa nel mito della poesia bucolica, quella del Verga, è, invece la Sicilia storica e reale, presente all’autore e vissuta attraverso le sue lacerazioni e contraddizioni.
Abbiamo accennato al rapporto uomo-natura in Teocrito, correlandolo a quello del mondo verghiano, cercando di comprenderne le analogie, come pure le necessarie contrapposizioni, afferenti alla diversità di temperie storica e alle istanze estetiche dei due autori.
Ci sembra, però, opportuno sottolineare che i due autori hanno senz’altro, nella composizione delle loro opere un criterio in comune: quello di identificare Il mondo della natura, dell’arte con il vero.
Leggiamo i versi 42-48 dalle Talisie
Così io dissi a bella posta, e il capraio dolcemente ridendo “ ll mio bastone-disse “ ti dono poiché ti sei formato sulla verità, un rampollo di Zeus. Poiché a me un architetto e fortemente antipatico il quale dice di voler costruire un edificio raggiungendo la cima dell’Oromedonte, e gli uccelli delle Muse che di faccia al cantore di Chio urlando a mò di cuculi si affaticano invano”
(trad.V.Pisani)
All’interno delle Talisie, in mezzo ad una natura festante e rigogliosa, si svolge un colloquio tra i due pastori Licida e Simichida.
Gli stessi pastori, anche se assumono la maschera bucolica, ci tramandano un messaggio assai significativo e tuttora vivo e presente: il bisogno di creare una poetica fondata sul vero.
Il vero, inoltre, concepito in questo brano, trova la sua realizzazione e compiutezza nel rapporto con una natura primigenia e feconda e rifugge dal mondo opulento e dalle sovrastrutture dalla città perché-dice Licida: “a me è antipatico un architetto il quale dice di voler costruire un edificio in cima all’Orodomonte”.
Teocrito, invero, come Verga rifugge dall’ambiente fatuo della città e cerca la sua ispirazione nel paesaggio agreste e nell’umile vita dei suoi personaggi.
La poetica di Teocrito, come lo sarà ancora più compiutamente quella di Verga, vuole essere scevra da un mondo falso e fatuo.
Prende in tal senso una precisa connotazione semantica il modo con cui Teocrito per bocca di Licida deride “ i poveri uccelli che gracidando pretendono di gareggiare con il cantore di Chio”
Anche in questa annotazione si evidenzia il postulato estetico, proposto da Teocrito: il rifiuto dell’imitazione e la creazione di poesia tutta incentrata sul vero.
Acquista, in tal modo un valore categoriale l’apostrofe di Licida rivolta al pastore Simichida “Il mio bastone ti dono perché sei tutto formato sulla verità”.
Il principio dell’opera d’arte, fondata sulla verità sarà perseguito, e lo testimoniano i suoi numerosi scritti al riguardo, anche da Verga, nei termini consentanei alla sua esperienza di uomo e letterato, decisamente distanti da quelli di Teocrito.
E’ importante, però, tenere presente che alcune categorie, relative alle teorie dell’estetica in letteratura, si perpetuano nella diacronia temporale.
Il che ci giustifica il fatto che Teocrito e Verga, autori appartenenti ad ere diverse e distanti, si prefiggono la stessa meta nello svolgimento dei loro itinerari narrativo-poetici: la verità.
Proseguendo il nostro discorso sul paesaggio verghiano, ed, in particolar modo, sul suo aspetto idilliaco, la nostra attenzione si volge ad un altro archetipo letterario: Virgilio.
Anche per Virgilio, come per Teocrito la Sicilia diventa il topos ideale, sede delle muse, che ispirano il canto pastorale.
Leggiamo nella Bucolica IV
Sicilides Musae, paulo malora canamus.
Non omnis arbusta iuvant humilesque myricae:
si canimus silvas, silvae sint consule dignae.
Ultima Cumai venit iam carminis aetas;
magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.
Cose cantiamo più grandi, Sicule Muse!
Non piaccion gli alberi a tutti né i tamarischi
umili.E allora cantiamo le selve
e siano le selve degne di un console.
L’ultimo tempo è venuto è venuto del carme Cumano;
una grande serie di secoli nasce da capo.
(trad. Cetrangolo).
Il poeta introducendo la quarta egloga, ricordando Teocrito, invoca la Sicilides Musae, nomina gli arbusta e le myricae, gli umili tamerici, piante di basso e tenue fusto, simbolo della poesia delle umili cose, che, però, non piacciono a tutti.
Ora il poeta si appresta a cantare un carme più solenne “paulo malora canamus” e a correlativo della sua poiesi pone le silvae, che rappresentano appunto l’ambiente e la materia pastorale di proporzioni più grandi, consule dignae.
Il console, a cui è dedicata l’egloga è Asinio Pollione, che nel 41 a.Chr. aveva trattato la pace di Brindisi, ponendo fine alle guerre civili e creando le condizioni per una pace duratura tra i popoli.
Per questo motivo nel carme Virgilio celebra l’avvento dell’età dell’oro.
Ci accorgiamo subito che l’unico motivo nel canto che può farci ricondurre a Verga è quello della denominazione della Sicilia, evocata,però,soltanto come sede delle Muse.
Le Sicule Muse ispirano al poeta latino un canto, che è un inno ad un mondo irenico, dove sta per avverarsi una palingenesi universale.
Soltanto c’è da rilevare che è proprio la Sicilia che, da Teocrito a Virgilio sino al Verga e a Quasimodo, costituisce il paradigma di una poesia, che concilia con il melos poetico l’accordo dell’uomo con la natura.
Ma questa tematica deve fare sempre i conti colla storia. Per questa ragione il locus amoenus di Virgilio, per antitesi in Verga spesso assumerà gli attributi del locus horridus.
Invero i due autori legano l’anima del paesaggio al reale storico, in cui vivono ed operano.
Virgilio inneggia all’aetas aurea, Verga, invece, scrive nella natura la sofferenza e il tragico destino degli uomini del suo tempo.
Si può cogliere, però, una certa analogia tra la rappresentazione paesaggistica virgiliana e quella verghiana: il sentimento della nostalgia.
Leggiamo nella Bucolica I. i versi 1-10
MELIBOEUS. Tityre, tu patulae recumbans sub tegmine fagi
silvestrem tenui Musam meditaris avena;
nos patriae finis et dulcia linquimus arva.
Nos patriam fugimus, tu Tityre, lentus in umbra
Formosam resonare doces Amarryllida silvas.
TITYRUS. O Meliboee, deus nobis hoc fecit.
Nacque erit ille mihi sempre deus, illius aram
Saepe tener nobis ab ovilibus ambuet agnus.
Ille meas errare boves, ut cernis, et ipsum
ludere quae vellem calamo permisit agresti.
MELIBEO. Titiro, sicuro tu giaci sotto i rami
larghi del faggio e componi un canto silvestre
col flauto sottile; e noi queste dolci campagne
lasciamo, noi in fuga dalla patria.Tu, Titiro,
tranquillo all’ombra insegni alle selve
a ripetere il nome della bella Amarillide
TITIRO. O Melibeo, un dio questa pace mi ha dato.
lui certo un dio sarà sempre per me; e spesso
trarrò dal mio ovile teneri agnelli
per bagnare la sua ara di sangue.
Mi disse che bene i miei bovi potevano errare,
come vedi, al pascolo; e disse che pure potevo
canti a mio piacimento comporre col calamo.
(Trad. Cetrangolo)
L’egogla fa riferimento ad un evento storico: la confisca dei terreni decisa dopo la battaglia di Filippi (42 a.Chr.) per compensare i veterani che avevano combattuto.
Colui che deve abbandonare le terre (Melibeo) viene colto da una struggente nostalgia “nos patriam fugimimus et dulcia linquimus arva”.
Un altro personaggio verghiano, ’Ntoni è costretto a lasciare la propria terra.
Analogo è il sentimento di nostalgia ,che accomuna i due personaggi. Profondamente diversa è, però, la loro condizione psicologico-esistenziale come pure , di conseguenza, diverso è lo sfondo paesaggistico dagli stessi contemplato.
In Melibeo il suo sentimento nostalgico si snoda in un afflato panico colla natura e si libra in un canto patetico-elegiaco per tutta la durata dell’egloga.
La natura viene concepita come una divinità da amare sempre e a questa si intona il canto dell’anima con un’armonia composita ed unitaria.
Anche quando nel paesaggio appaiono ombre “ maiores cadunt altis de montibus umbrae” con specifico riferimento ai tempi bui della storia, il pastoreintona il suo canto in armonia colla natura con una mestizia velata.
Commenta il Funaioli
“ Sulla tragedia umana, intessuta di lacrime amare,di ricordi, di commozione, scende come un oblio lene della faticosa vita,la sera di un pomeriggio di autunno coi suoi casolari fumanti di lontano,colle sue ombre che sempre più grandi cadono dai monti e scolorano le case e ne velano il pianto. E’ appunto di Virgilio far svaporare la tristezza, soprattutto la più grande dentro una scena dolcissima e ampia”.
La suavitas del paesaggio fa contrappunto allo status animi di Melibeo .
Mondo della natura e sentimenti del personaggio si confondono, in un’inscindibile e costante unitarietà, facendo risuonare per tutta l’egloga pure e pacate note di elegia.
Nella pagina verghiana, che descrive l’addio di ‘Ntoni, lo scenario non si sviluppa con un continuum di momenti idilliaci, anzi nel momento stesso in cui nasce l’idillio si avverte da questo il doloroso distacco con l’incombere di un fato indomito ed inarrestabile.
Soltanto per qualche istante la voce della natura parla a ‘Ntoni con il gorgogliare del mare che non ha paese “nemmeno lui”. Scorge le luci dell’alba, ma dovrà allontanarsi, esule senza ritorno.
Non vi è nell’episodio di ‘’Ntoni quella visione panica della natura, in cui si immerge Melibeo, traendone conforto.
Sovrasta la necessità del distacco,che rende ancora più amaro e struggente il sentimento di nostalgia.
A ‘Ntoni non è concesso soffermarsi a contemplare la natura o a condividere con altri, come fa Melibeo con Titiro, la sua pena.
Lo squarcio idillico della natura scompare nel momento stesso, in cui deve intraprendere il suo ignoto destino, che lo travolgerà.
Solitudine e desolazione,lo ripetiamo, sono le note che sottolineano il paesaggio verghiano,che si presenta naturalmente assai distante da quello evocato nell’egloga virgiliana.
Un altro aspetto presente nel Verga e ravvisabile in Virgilio è la concezione del labor.
Leggiamo Virgilio – Dalle Georgiche- I ww121-148
Pater ipse colendi
haud facilem esse viam voluit, primusque per artem
movit agros, curis acuens mortalia corda
nec torpere gravi passus sua regna veterno.
Ante Iovem nulli subigebant arva coloni:
ne signare quidam aut partiri limite campum
fas erat; in medium quaerebant, ipsaque tellus
omnia liberius nullo poscente ferebat.
Ille malum virus sepentibus addidit atris
predarique lupos iussit pontem moveri,
mellaque decussit foliis ignemque removit
et passim rivis currentia vina repressit,
ut varias usus meditando eextunderet artis
paulatim, et sulcis frumenti quaereret herbam,
ut sulcis venis abstrusum extunderet ignem.
Tunc alnos primum fluivi sensere cavatas;
navita tum stellis numeros et nomina fecit
Pleiadas,Hyadas claramque Lycaonis Arcton.
Tum laqueis captare feras et fallere visco
inventum et magnos canibus circumdare saltus;
atque alius latum funda iam verberat amnem
alta petens, pelogoque alius trait umida lina.
Tum ferri rigor atque argutae lamina serrae
-nam primi cuneis scindebant fissile lignum-
tum variae venere artes.Labor omia vincit
improbus et duris urgens in rebus egestas.
Prima Ceres ferro mortalis vertere terram
Instituit, cum iam glandes atque arbusta sacrae
deficerent silvae et victum Dodona negaret.
Mox et frumentis labor additus, ut mala culmos
esse robigo segnisque horreret in arvis
carduus: intereunt segetes,subit aspera silva
lappaeque tribolique, interque nitentia culta
infelix lolium et steriles dominantur avenae.
Quod nisi et adsiduis herbam insectare rastris
et sonitu terrebis avis et ruris opaci
falce tremens umbras votisque vocaveris imbrem,
heu magnum alterius frusta spectabis acervum
concussaque famem in silvis solabere quercu
Le cose dei campi volle difficile il Padre
stesso e primo li mosse per arte pungendo
i cuori mortali d’affanno né sonno permise
pesante al regno. Prima di Giove
non c’erano coloni che arassero i campi,
neppure segnare confini o dividerle
era lecito; i frutti in comune ed essa la terra
ogni cosa donava senza richiesta di alcuno.
Ma quello aggiunse il veleno ai serpenti,
impose che i lupi predassero, che il mare bollisse,
il miele tolse alle foglie,il fuoco nascose
e i vini scorrenti e i ruscelli dovunque richiuse:
perché meditando l’uomo foggiasse col tempo
le arti diverse e l’erba del grano cercasse
coi solchi e il fuoco nascosto destasse dai sassi.
Allora sentirono i fiumi gli ontani incavati,
allora diede il pilota numeri e nomi
alle stelle: Pleiadi,Iadi e l’Orsa fulgente
di Licaone;allora s’inventa di prender le fiere
coi lacci, ingannarle col vischio e di cingere
i grandi boschi coi cani; altri colpisce
di fionda vaste fiumane,altri umide reti
tira al mare;allora il rigore del ferro,
le lame stridenti di sega (giacché i primi
spaccavano il legno con i cunei) e nacquero allora
le arti diverse. Tutto vince il lavoro
continuo e nell’aspra giornata l’urgente miseria.
Cerere apprese per prima ai mortali l’aratro
poi che le ghiande e i corbezzoli eran del bosco
sacro scomparsi e Dodona negava ogni cibo.
Anche il frumento sacro s’ammala: ruggine trista
corrode gli steli;s’erge nei campi infecondo
il cardo; muore la messe,un’aspra sterpaglia
sottentra di pruni e di lappole e tra i colti
unitile domina il loglio e sterile avena.
Ché se non rimuovi assiduo l’erba coi rastri
e non metti paura col suono degli uccelli,
se l’ombra non togli di rami frondosi alla terra
e non supplichi pioggia con voti, invano
stupito vedrai de’ vicini i gran mucchi e la fame
tu sazierai scotendo nei boschi le querce.
(trad. Cetrangolo)
Abbiamo riportato questo brano virgiliano piuttosto lungo in quanto riteniamo che contenga topoi ravvisabili nell’opera verghiana : la tensione agonistica dell’uomo con la terra e la necessarietà del labor.
E’ , infatti, all’interno del brano che Virgilio, che prima nelle Bucoliche aveva cantato Omnia vincit Amor, celebra la forza operosa per superare, le avversità della natura e della vita e la miseria……………….Labor omnia vicit/ improbus et duris urgens in rebus egestas.
Dice il Rostagni : (A.Rostagni- Letteratura latina-vol.II-Utet-Torino 1955 a pag. 51)
“ Il mondo irreale fittizio dei pastori arcadici si allontana più che mai per cedere il passo alla realtà che è fatta di cose comuni, dure, aspre, rozze,di lavoro, di sforzo, di azione…………………….nulla si ottiene dalla terra che non sia pagato con sudore e pianto; le forze misteriose della natura minacciano di ora in ora la vita, gli affetti e l’opera umana, piombano sull’uomo e su tutto ciò che alluomo è caro : sugli animali, sulle piante, sul seminato, sui raccolti e sovvertono tutto,costringendo a riprendere con pena infinita l’opera sconvolta”.
Seguendo l’acuto giudizio critico del Rostagni , ci ricordiamo dei personaggi verghiani e del mondo che li circonda.
Comprendiamo innanzi tutto che sia Virgilio che Verga attingono alle forme estetiche più evolute e più significative allorquando fanno della realtà la substantia della loro ispirazione e del loro discorso letterario.
La realtà, cui volge lo sguardo Virgilio è la medesima,che viene indagata da Verga; si compone di uomini comuni che lottano con indomito travaglio contro le forze misteriose della vita.
L’umanità ,vediamo, rappresentata sia da Virgilio sia da Verga, sente l’incombere di una minaccia, che può sconvolgere nell’uomo tutta quantala vita e soffocarne i più intimi sentimenti.
Bisogna, inoltre, precisare che l’approdo al vero, per entrambi gli autori Virgilio e Verga, segna la loro estrema maturazione nella sfera non soltanto artistica, ma anche in quella umana, culturale e spirituale.
Virgilio si proietta nel vero dopo la parentesi arcadica,Verga sente,invece, l’esigenza di imprimere il vero nella sua opera dopo un primo approccio alle tematica della scapigliatura.
In tal modo i due autori,calando il reale nella loro produzione, congiungono al fenomeno letterario quello storico e colloquiano con il loro pubblico con forti motivazioni di carattere etico-sociali.
Non dobbiamo, però, in virtù delle enunciazioni espresse, pervenire ad un’affrettata conclusione, che ci indurrebbe a considerare il mondo poetico virgiliano del tutto coincidente con quello verghiano.
Del tutto diversa e assai distante è la temperie storico-culturale, in cui i due autori operano e vivono.
Virgilio scrive le Georgiche tra il 37 e 30 a. Chr., nel momento in cui la politica di Ottaviano, compresa quella agricola coincideva con i suoi interessi etico-religiosi. Donde la concezione del labor , che sta alla base del riscatto e della redenzione del suolo italico.
Verga,invece, vive nell’Italia postunitaria, che pagava gravemente il prezzo dell’unificazione, accentuando il divario tra Nord e Sud, nel pieno fermento della questione meridionale e nel turbinio di questioni sociali che non trovavano alcuna soluzione.
Ci affidiamo al testo proposto per meglio comprendere la consonanza dei motivi ispiratori nei due autori e al contempo le contrapposizioni.
…………………………..Pater ipse colendi
haud facilem esse voluti vitam
In questi versi si propone la necessità del labor per l’uomo ai fini della sua sussistenza in un mondo irenico.
Il lavoro degli umili nel Verga, invece, ha un aspetto disumano ignoto a Virgilio.
I personaggi verghiani erano sottoposti alle leggi inique del tempo e allo sfruttamento. Da qui la disperazione e la desolazione dei vinti, che si muovono in un paesaggio, che si colorava delle fosche tinte della loro dolorosa situazione in un attonito silenzio.
Nel testo virgiliano, invece, è ipse pater-Giove,che impone agli uomini la dura fatica dei campi.
La presenza del pater ipse-Giove ci riconduce alla concezione del theòs eurghethès esiodeo.
Il deus-pater, ammonendo gli uomini al lavoro dei campi, preconizza un mondo nuovo,fondato sul bene e la giustizia.
Commenta L.Alnsonsi (L. Alfonsi-Letteratura latina- Sansoni- Firenze-1960 a pag. 208 )
“ Il mondo diventa mondo di giustizia e di lavoro, che trionfa di ogni avversità: iustissima è la tellus ed omnia vicit labor. In questa vasta economia, dove la fatica dell’uomo non è più senza scopo, ma pare sia il dovere, sia il compito morale di ognuno di noi, la realtà sociale acquista contorni ben precisati e si identifica con l’unione tra l’Italia e Roma e con la funzione direttiva affidata a quest’ultima in tutto il mondo…………………………………..Ben poche opere hanno contenuto sociale così marcato, e condizionano in tal misura la vita e la storia alla quotidiana fatica dell’umile lavoratore, riconoscendo a questa la capacità di redenzione”.
Nel testo virgiliano viene esplicitata la volontà del numen.
Giove ha compiuto quest’azione nell’intento che l’uomo meditando foggiasse col tempo le arti diverse e l’erba dal grano cercasse ut varias usus meditando extunderet artis/ paulatim et sulcis frumenti quaereret herbam.
La forza operosa, che spinge l’uomo al culto della terra per ricavarne i propri mezzi di sostentamento, è anche presente nel Verga.
Nel mondo verghiano, però,è assente il numen e quasi sempre la fatica dell’uomo viene vanificata o dall’imperversare di calamità naturali ovvero dall’oppressione, esercitata dalla miope politica del tempo nei confronti degli umili, che ci appaiono vinti e dalla natura e dalla storia.
Questa visione pessimistica viene rappresentata,come abbiamo detto, dal Verga colla metafora del mare ovvero della fiumana del progresso, che tutto travolge,uomini e cose.
Anche nel testo virgiliano è presente il mare. Ed è lo stesso Giove, che iussit pontemque moveri. Giove comanda che il mare venga agitato, ribadendo la volontà ,espressa in tutto quanto il brano, di infondere negli uomini la capacità di opporsi in forma antagonistica alla natura.
Da questa contrapposizione uomo-natura, elemento dominante anche nell’opera verghiana, l’uomo in Virgilio sembra uscirne vittorioso. Non così avviene,per le ragioni innanzi espresse, per il personaggio verghiano.
Nell’antagonismo con la natura l’uomo in Virgilio prende vigore e rivela la sua stessa identità di essere,che vive nella natura e colla natura. E dell’uomo la natura sente la presenza tunc alnos primum fluivi sensere cavatas (allora sentirono per prima gli ontani incavati).
Il tunc, posto all’inizio del verso 136,assume un valore semantico pregante.
Da allora, infatti, l’uomo non solo sente di vivere in perfetta armonia con la natura, ma si evolve nella conoscenza e dà un nome alle cose navita tum stellis numeros et nomina fecit.
L’iterarsi delle locuzioni avverbiali di tempo, tunc all’inizio del verso 136 e tum, all’interno del verso susseguente, se da una parte ci danno la viva sensazione dell’immediatezza con cui il navita scopre il mondo e dà un nome alle cose, dall’altra ci spinge ad un discorso più ampio sul problema sul problema gnoseologico, legato al linguaggio,in senso diacronico..La conoscenza nasce nell’uomo in un rapporto di intima connessione colla natura. E’ una conoscenza genuina e spontanea katà phùsin,da cui si origina quel linguaggio,che non è ancora lògos, ma,che in quanto parola dell’anima si accorda in ogni tempo alle visioni idilliache e alla compiuta espressione dei sentimenti umani.Il navigante attribuisce un nome alle stelle e alle costellazioni : Pleiadi, Iadi, Orsa ed indubbiamente sarà colpito dallo stupore dell’incanto della natura.La lezione virgiliana,infatti,vediamo,è anche presente nel Verga, che propone un linguaggio sempre aderente alla realtà, anzi possiamo dire che converte i segni della natura in segni linguistici.La stessa parola verghiana assume un tono di più elevata e commossa poesia nel momento in cui sostanzia il vissuto dell’uomo con il mondo che lo circonda.Come il navigante virgiliano anche ‘Ntoni,che, però, si sente vicino al naufragio esistenziale, scorge le Pleiadi.“Sulla riva in fondo al mare cominciavano a formicolare dei lumi. Egli levò il capo a guardare i Tre Re e la Puddara, che annunziava l’alba, come l’aveva vista tante volte”.E’ significativo che il Verga nomini le Pleiadi Puddara, proprio nell’accezione dialettale, per rendere più familiare l’evento del suo insorgere a ‘Ntoni nel momento del distacco.Ne nasce una suggestione tutta particolare,imperniata su un realismo linguistico, stilato in corrispondenza al vissuto e all’emotività del personaggio.Si può dedurre,allora, che in Virgilio come in Verga l’unica parola possibile, capace di estrinsecare compiutamente i sentimenti dell’uomo e di condurlo nell’aura dell’idillio,è quella autentica,ingenerata e vissuta nell’elementarità ed essenzialità del mondo della natura.Proseguendo nella lettura del testo virgiliano conosciamo che Cerere apprese per prima ai mortali l’aratro dopo che Dodona aveva negato agli uomini i frutti che copiosamente crescevano nel bosco. Prima Ceres ferro mortalis vertere terram/ instituit,cum iam glandes atque arbusta sacrae/ deficerent silvae et victum Dodona negaret. La dea della terra,che affida all’uomo l’aratro ha due intenti, l’uno complementare all’altro : quello di salvare la vegetazione dall’insorgere della ruggine trista e quello di preservare l’uomo dall’egestas.Ammonisce,infine,il poeta l’uomo ad attendere con scrupolosa cura ai lavori dei campi,senza la quale gli sarà impossibile evitare la miseria, mentre non gli resterà altro da fare che guardare i grandi mucchi dei vicini, ammassati per opera del duro lavoro.Anche quest’ultima parte del brano virgiliano ci conduce ad alcuni momenti della narrativa verghiana.Nei versi 150-154 si parla della robigo che distrugge la vegetazione,mentre Verga intitola una sua novella Malaria.Nei versi susseguenti 155-159 si parla del modo, con cui è possibile vincere l’egestas e non stare a guardare i cumuli dei vicini.I cumuli ammassati non possono che rimandare alla mente la “roba” tanto amata ed idolatrata da Mazzarò e da mastro-don Gesualdo.Pur nell’analogia di elementi, compresenti sia in Virgilio sia in Verga, è d’uopo, enunciarne, sia pure sommariamente le contrapposizioni. La robigo,di cui parla Virgilio, è un male, che si può estirpare con il frumentis labor additus.Molto più angosciante e funesta è la descrizione in Verga della malaria: “E’ la malaria che vi entra nelle ossa col pane che mangiate…………” questa è la desolante conclusione cui approda l’autore raffigurando,altresì, nel paesaggio stesso la condizione della fragilità umana. Il deus presente in Virgilio è assente nel Verga colle conseguenze che ne derivano.Anche l’accenno ai cumuli, ammassati e, comunque alla roba,che fanno parte integrante del paesaggio, in cui si muovono Mazzarò e mastro-don Gesualdo, introduce una tematica, che si distanzia nettamente da quella virgiliana.Per Virgilio ognuno è in grado, con l’assiduità del lavoro, di procacciarsi il suo cumulo, derivante dai frutti della terra e, favorevole per il sostentamento fruibile per il trascorrere di una vita serena, mentre per Verga soltanto alcuni, come per l’appunto Mazzarò e mastro-don Gesualdo, che della roba hanno fatto la loro unica divinità e che sono riusciti a superare la china della miseria, possono godere di questo bene. Attorno a loro una folla di derelitti e sfruttati che non riescono a levare il capo dalla miseria.Mastro-don Gesualdo,dopo tanti stenti e fatiche, guarda con soddisfazione i covoni ammassati in mucchi della sua roba e gode alla vista di quel grande magazzino,in cui si accumulava la sua ricchezza e che gli sembrava immenso nel buio, mentre una striscia argentea della luna lo illuminava.Per Mazzarò e per mastro-don Gesualdo lo stesso paesaggio,in cui è assente il theòs eurghethès , s’identifica con la roba.Le enunciazioni suesposte ci sembra che chiariscano l’assunto che Virgilio e Verga sono accomunati da interessi e motivi d’ispirazione, ma che sono, naturalmente distanti, anche per ragioni storiche, nell’ottica concettuale e culturale, oltre che nella poiesi artistica, sviluppata dai due autori nelle forme personali d’originalità ed autenticità. Analogo discorso possiamo condurre rapportando l’opera di Verga a quella di Teocrito. Concludendo riteniamo di potere affermare che sia stato doveroso riproporre la lezione degli autori classici e il loro messaggio, implicito per alcuni aspetti anche nell’opera verghiana.Il che ci convince a considerare che il colloquio tra intellettuale e pubblico, oltre che nella specificità del contingente storico, contiene in sé un valore assoluto e metatemporale.
.
